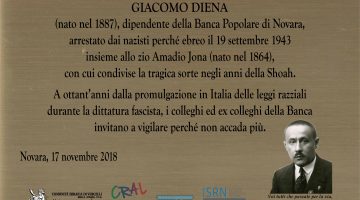Elisa Malvestito
articolo pubblicato ne “l’impegno”, a. XXXVI, n. s., n. 2, dicembre 2016
I sommersi e i salvati: un’introduzione
Primo Levi è il testimone per eccellenza. Tutta la sua produzione letteraria, che si colloca tra il ritorno da Auschwitz e la sua morte, è influenzata dall’esperienza del lager. Come dice Ernesto Ferrero nella biografia dedicata allo scrittore-testimone, in Levi «è sempre stata forte […] la consapevolezza che Auschwitz non è stato un accidente isolato»[1] e questa consapevolezza l’ha spinto non solo a raccontare la sua personale esperienza da ex deportato, ma a indagare e a ricostruire il fenomeno del lager con gli occhi dello scienziato e dell’antropologo per rispondere a domande urgenti e attuali: quanto è rimasto e/o sta tornando del mondo concentrazionario?
Se a questa domanda Levi prova a rispondere nell’ultimo libro che pubblica qualche mese prima della sua morte[2], il tema del racconto come dovere del “salvato”[3] era già presente nella prima opera dell’autore dedicata alla deportazione, il celeberrimo volume “Se questo è un uomo”[4], ma con toni diversi rispetto all’ultimo libro che, quindi, chiude in un cerchio la sua produzione letteraria. «Nel suo volo circolare Levi torna al Lager, o meglio, non l’ha mai abbandonato»[5].
“I sommersi e i salvati” rappresenta il frutto di uno studio che impegna Levi già dalla metà degli anni settanta, come testimonia un’intervista rilasciata dallo scrittore a Giorgina Arian Levi nel 1979[6]. Nella pubblicazione infatti confluiscono testi scritti dall’autore in occasioni differenti, che vengono raccolti, sistemati e organizzati negli otto capitoli che compongono il volume.
L’approccio di Levi rispetto all’esperienza del lager in questo libro è molto diverso da quello che emerge dalla lettura di “Se questo è un uomo”. Ne “I sommersi e i salvati” Levi affronta l’analisi del sistema concentrazionario non solo da testimone sopravvissuto, ma anche e soprattutto da studioso e scienziato. «Questo libro intende contribuire a chiarire alcuni aspetti del fenomeno Lager che ancora appaiono oscuri»[7], afferma l’autore nella prefazione. Vuole quindi approfondire l’analisi antropologica del fenomeno dichiarando però di non avere intenzione di «fare opera di storico, cioè di esaminare esaustivamente le fonti»[8]. A partire dalla sua esperienza e dalla lettura di altre testimonianze e ricerche già condotte sul tema, Primo Levi restituisce al lettore una vera e propria indagine sociologica sul sistema concentrazionario applicando quel metodo scientifico di stampo illuministico a lui così familiare. Levi studia l’uomo e la sua degenerazione senza alcuna volontà o pretesa di arrivare alla «radice assoluta della conoscenza». Descrive la realtà umana che ha dato vita al sistema concentrazionario ma, a differenza di Hannah Arendt, non arriva a teorizzare il male che ne sta alla base. «Da buon chimico, Levi non si è stancato di distinguere gli elementi, di pesarli, di analizzare le loro proprietà. La conoscenza, per lui, passa dalle mani, dal naso, dai sensi, come accade a “ogni ingenuo realista”. Non ha l’ambizione filosofica di arrivare alla radice assoluta della conoscenza, vuole soltanto “scendere da un livello all’altro, cercando ogni volta di comprendere un po’ di più rispetto a prima”. […] Sa bene di non poter attingere la verità o la realtà»[9].
La memoria. Limiti e procedimenti
Uno dei temi centrali che apre e chiude l’ultimo libro pubblicato da Levi è quello della memoria. Levi è consapevole dell’importanza che la memoria ha non solo per la singola vita dell’individuo, ma anche e soprattutto per una comunità. Allo stesso tempo però ne riconosce i limiti e i difetti. «La memoria umana è uno strumento meraviglioso, ma fallace»[10].
Se il “salvato” ha il dovere di raccontare, alla base del racconto del testimone c’è il ricordo che egli ha della sua esperienza del lager e questo ricordo è, necessariamente, un ricordo mediato. La memoria tende infatti a modificare, semplificare e addirittura cancellare i ricordi di un avvenimento e i motivi sono molteplici. Innanzitutto, dice Levi, sul processo mnemonico incide l’oblio fisiologico dovuto allo scorrere del tempo: man mano che il tempo passa, i ricordi di semplificano e tendono a cancellarsi. Oltre a questo, possono agire altri fattori quali le rimozioni forzate, le repressioni o l’interferenza di altri ricordi.
Ancora più problematica è la memoria degli eventi storici traumatici, come quello della Shoah, che non solo tende naturalmente a modificarsi o cancellarsi, ma diventa oggetto di rivisitazioni volontarie o involontarie, soprattutto perché, come nel caso del lager, chi può raccontare è la vittima sopravvissuta o l’oppressore. La fallacità della memoria crea dunque una «paradossale analogia» tra il salvato e il carnefice, paradossale appunto perché se da un punto di vista teorico i due soggetti possono essere messi sullo stesso piano, da un punto di vista etico e morale non sono per nulla interscambiabili.
La memoria delle vittime e dei carnefici opera dunque secondo procedure simili, ma se i primi tendono a cancellare o modificare il ricordo perché ricordare è doloroso, i secondi invece rimuovono la memoria dell’atto per evitare il senso di colpa. Questo è ad esempio quello che accade a Louis Darquier de Pellepoix, commissario addetto alle questioni ebraiche del governo di Vichy nel 1942 che, secondo Levi, rappresenta «il caso tipico di chi, avvezzo a mentire pubblicamente, finisce col mentire anche in privato, anche a se stesso, e coll’edificarsi una verità confortevole che gli consente di vivere in pace»[11]. Anche le vittime tendono a rimuovere la memoria, o almeno a modificarla, ma, a differenza degli oppressori, manca il dolo. La realtà viene modificata o cancellata ma per un semplice istinto di conservazione. «Chi riceve un’ingiustizia o un’offesa non ha bisogno di elaborare bugie per discolparsi di una colpa che non ha […] ma questo non esclude che anche i suoi ricordi possano essere alterati»[12].
Il dovere di raccontare. Memoria e scrittura
Dunque è difficile ricostruire la verità sui lager dato che gli unici che possono raccontare, ovvero i carnefici o le vittime sopravvissute, hanno ricordi falsati rispetto alla verità dei fatti. Nonostante questo però secondo Levi raccontare e condividere con gli altri i propri ricordi è fondamentale non solo per scopi terapeutici, ma anche e soprattutto per contribuire alla vita civile del proprio tempo. Dice Levi nella conclusione della sua riflessione: «Per noi parlare con i giovani è sempre più difficile. Lo percepiamo come un dovere, ed insieme come un rischio: il rischio di apparire anacronistici, di non essere ascoltati. Dobbiamo essere ascoltati: al di sopra delle nostre esperienze individuali, siamo stati collettivamente testimoni di un evento fondamentale ed inaspettato, fondamentale appunto perché inaspettato, non previsto da nessuno. È avvenuto contro ogni previsione; è avvenuto in Europa […]. È avvenuto, quindi può accadere di nuovo: questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire»[13].
La testimonianza per Levi, così come per un altro noto intellettuale ed ex deportato che dedica numerosi testi alla sua riflessione sulla Shoah, Jean Améry, non risponde soltanto a un bisogno individuale di tipo psicanalitico, ma rappresenta una risposta al bisogno morale della società. Bisogna impedire che il male prodotto ad Auschwitz venga semplificato o, ancora peggio, dimenticato, e per fare questo il testimone ha il dovere di raccontare perché attraverso il suo racconto l’umanità migliora la conoscenza che ha di sé e dei propri limiti e si evita la ripetizione del fenomeno.
Il monito con il quale Levi chiude questo suo ultimo saggio[14] non solo rappresenta la conclusione della sua produzione letteraria, ma anche racchiude la riflessione sul significato che egli stesso attribuisce alla sua esperienza nel lager. Queste frasi infatti possono essere lette come una risposta a quell’imperativo morale che Levi aveva affidato alla poesia d’apertura di “Se questo è un uomo”: «[…] Meditate che questo è stato:/ vi comando queste parole./ Scolpitele nel vostro cuore […]»[15]. Se nel libro del 1947 questo imperativo non trovava ancora una risposta concreta, ne “I sommersi e i salvati” Levi prova a rispondere e comunica la sua proposta alle nuove generazioni.
Le parole, la memoria, i ricordi non solo hanno permesso a Primo Levi di sopravvivere ad Auschwitz, di trovare un senso all’esperienza del lager e alla vita dopo il lager. Le parole per Levi rappresentano un impegno, un dovere civico nei confronti non solo di quanti dal lager non sono tornati, ma anche e soprattutto nei confronti di quanti il lager non l’hanno conosciuto e che, potenzialmente, potrebbero rivederlo, sebbene in altre forme. «Può accadere, e dappertutto. Non intendo né posso dire che avverrà […] è poco probabile che si verifichino di nuovo, simultaneamente, tutti i fattori che hanno scatenato la follia nazista, ma si profilano alcuni segnali precursori»[16].
La scrittura rappresenta quindi per Levi l’arma della memoria e, nonostante i suoi limiti e i suoi difetti, la memoria rappresenta il vero impegno che il “salvato”, colui che è sopravvissuto per pura casualità, deve assumersi di fronte alla Storia e, soprattutto, di fronte al futuro.
Note
[1] ⇑ Ernesto Ferrero, Primo Levi. La vita, le opere, Torino, Einaudi, 2007, p. 112.
[2] ⇑ I sommersi e i salvati viene pubblicato da Einaudi nel 1986.
[3] ⇑ Il termine viene utilizzato da Primo Levi già nel libro Se questo è un uomo per identificare il deportato che è sopravvissuto al lager per caso (come Levi) o perché compromesso (il cosiddetto “prominente”) e viene utilizzato in contrapposizione al termine “sommerso” che indica il deportato mai tornato. Le categorie del “sommerso” e del “salvato” saranno poi riprese e teorizzate in modo definitivo nell’ultima pubblicazione di Levi.
[4] ⇑ Se questo è un uomo viene scritto da Primo Levi appena dopo il suo rientro da Auschwitz. La prima edizione venne stampata nel 1947 da una piccola casa editrice torinese, la De Silva, diretta da Franco Antonicelli, dopo che alcuni grandi editori, tra cui Einaudi, avevano rifiutato il testo. Solo nel 1958 Se questo è un uomo verrà ristampato da Einaudi nella collana “Saggi”.
[5] ⇑ E. Ferrero, op. cit., p. 112.
[6] ⇑ «Il tema dei rapporti tra l’oppressore e l’oppresso, fra la vittima e il carnefice, nelle sue sfumature è un tema da indagare», in E. Ferrero, op. cit., p. 112.
[7] ⇑ Primo Levi, I sommersi e i salvati, Torino, Einaudi, 1986, p. 11.
[8] ⇑ Ibidem.
[9] ⇑ E. Ferrero, op. cit., pp. 117118.
[10] ⇑ P. Levi, op. cit., p. 13.
[11] ⇑ Idem, p. 17.
[12] ⇑ Idem, p. 21.
[13] ⇑ Idem, p. 164.
[14] ⇑ È difficile inserire questo volume nella classificazione tradizionale dei generi letterari. Scrive Traverso: «[…] il suo saggio costituisce uno dei rari esperimenti di confronto e d’integrazione tra storia e memoria in un’epoca in cui i crimini del nazismo sono diventati oggetto di storia. […]. Il risultato è un saggio letterario di tipo nuovo, impossibile da catalogare, che infrange le barriere fra la testimonianza e il saggio critico, superandone i limiti rispettivi». Enzo Traverso, Auschwitz e gli intellettuali. La Shoah nella cultura del dopoguerra, Bologna, Il Mulino, 2004, p. 173.
[15] ⇑ P. Levi, Se questo è un uomo, Torino, Einaudi, 2005, p. 7.
[15] ⇑ Id, I sommersi e i salvati, cit., p. 164.