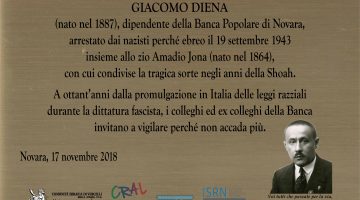Cristina Merlo[*]
articolo pubblicato ne “l’impegno”, a. XXIV, n. s., n. 1, giugno 2004
Per approfondire e concretizzare la situazione degli ebrei a Vercelli non solo da un punto di vista statistico, ma anche umano, sono stati presi in considerazione due manoscritti e sono state effettuate quattro interviste ad individui appartenenti (complessivamente) a cinque famiglie ebraiche vercellesi[1]: ne sono emerse storie diverse per vicende ed estrazione sociale e culturale, ma simili fra loro per terrore e sofferenza.
I casi esaminati non sono di famiglie allargate, poiché costituite dai genitori, uno o due figli e un fratello/sorella o genitore della coppia; si trattava di ebrei che vivevano e lavoravano in Vercelli, del tutto integrati nel piccolo mondo di provincia.
La famiglia Colombo
La famiglia Colombo era costituita dal padre Rodolfo, dalla madre Elvira Ancona e dal figlio Dario e alloggiava in piazza Massimo d’Azeglio. Si poteva considerare una famiglia agiata grazie alla stabilità economica derivante dall’attività di Rodolfo, laureato in economia e commercio e libero professionista.
Il figlio Dario ne parla così: «Mio padre che era dottore commercialista, mia madre che era, allora non si chiamavano casalinghe, ma benestanti e così sono nato da una famiglia abbastanza agiata… Mio padre era laureato in economia e commercio, era un bocconiano, la laurea di mio padre, che io ho tuttora in casa, porta la firma di Luigi Einaudi. Esercitava qua a Vercelli. […] Avevamo persone di servizio che poi, naturalmente, con le leggi razziali, non si potevano più avere, ma che erano tollerate lo stesso, la Questura non diceva niente».
Dario era invece studente e come lui stesso afferma: «Ho frequentato l’asilo infantile Levi ed è sempre lì che io sono andato a scuola, in Italia, sino a dopo, quando sono tornato, alla Liberazione, perché questo asilo non esisteva più».
Una famiglia “mista”: i Pollarolo
La famiglia di Mario Pollarolo era costituita dal padre Angelo, dalla madre Maria Sacerdote, dalla zia Sellina, sorella della madre, e dallo stesso Mario; vivevano in corso Carlo Alberto 48.
Mario, durante l’intervista, afferma che la sua era una famiglia di lavoratori e di tradizione operaia: «Il papà era del ’91, ha fatto la guerra del ’15-18, poi ha sempre lavorato, lui, più che altro, faceva il commesso di negozio, solo un breve periodo ha fatto la Chatillon […] C’è stato un periodo, prima della guerra, che avevamo un negozio di pollame in via Foa, proprio nel ghetto di Vercelli […] era carne che gli ebrei potevano mangiare […] facevamo il pollame; c’era anche salami, salami d’oca, perché appunto, non mangiando il maiale, si faceva i salami e le salcicce d’oca, le mandavamo in giro, mandavamo le cassette in giro per l’Italia, addirittura; poi non è andata bene, perché con le leggi razziali, che sono sopravvenute, poi le restrizioni e via dicendo, siccome la titolare del negozio risultava mia madre, allora abbiamo dovuto chiudere. […] Sì, questo negozio è durato qualche anno, insomma abbastanza, poi mio padre è andato a lavorare alla Chatillon, faceva il magazziniere alla Chatillon, ed è stato lì fino alla pensione. Mia madre ha sempre lavorato in una ditta, ditta Cantoni di macchine agricole, come segretaria, ha sempre lavorato lì, ha passato la vita lì dentro. […] E mia zia è sempre rimasta a casa, faceva i lavori, curava me, curava tutta la famiglia, era proprio di famiglia, diciamo, non si è mai sposata, quindi siamo rimasti sempre insieme».
Mario invece interrompe gli studi dopo il secondo anno delle scuole superiori e inizia a lavorare: «Io sono stato allevato, da bambino, nell’asilo ebraico, ho fatto prima, seconda e terza elementare sempre nelle scuole ebraiche di Vercelli, poi la scuola ha chiuso per mancanza di allievi, eravamo pochissimi, allora sono andato poi alle scuole pubbliche, normali, ho fatto la quinta nella scuola pubblica, quarta e quinta e poi sono andato all’Istituto Cavour per geometri; subentrate le leggi razziali mi hanno cacciato fuori, ho incominciato a lavorare. Sono andato a fare l’operaio, sono andato in una ditta, prima, sono stato un anno circa, poi sono passato in quest’altra ditta [la Cantoni], io ho sempre lavorato, ho sempre fatto l’operaio».
La famiglia Pollarolo era una famiglia “mista”: come già accennato tali famiglie costituirono un problema di difficile soluzione per la legislazione razziale fascista, in quanto i provvedimenti legislativi imponevano una netta separazione tra ebrei e “ariani” anche all’interno di ogni singola famiglia. Il padre di Mario era cattolico, mentre la moglie e la cognata erano ebree; il figlio Mario fu educato secondo la religione ebraica come voleva la madre, senza che il padre si opponesse. Vivere in una famiglia “mista” non costituì un disagio per nessuno dei suoi componenti, neppure per Mario, il “figlio misto”, nato da padre “ariano” e da madre di “razza” ebraica. Anche i parenti dei Pollarolo avevano accettato quasi tutti l’unione di un cristiano con un’ebrea.
Ecco come Mario Pollarolo racconta la sua storia: «Mio padre non era ebreo […] sì, se ne fregavano tutti nel modo più assoluto; uno dei fratelli di mio padre era un comunista convinto, un altro era un anarchico addirittura, quindi figuriamoci, se ne fregavano altamente… Le sorelle invece, un po’… si sa le donne… […] Mio padre aveva un cugino, in secondo grado, prete, che era parroco della chiesa di San Michele e, mi raccontava mio padre che un giorno uscendo di casa ha trovato questo cugino prete e gli ha chiesto: “Ma ti sei sposato?”, e lui ha detto: “Sì”, “E chi hai sposato?”, “Ho sposato un’ebrea’” “Oh!, ma no, ma no, ma cosa hai fatto”, e lui dice: “Non solo ho sposato un’ebrea, il figlio l’ho fatto ebreo”, “Oh!, ma no”, gli ha detto: “Vieni in chiesa che aggiustiamo tutto”, e mio padre ha detto: “È già tutto aggiustato, non c’è niente da aggiustare, va bene così”. Non lo ha più salutato».
Tra le carte della Prefettura rintracciate all’Archivio di Stato di Vercelli sono state ritrovate le “schedine” personali riguardanti “beni ebraici” e appartenenza alla “razza” ebraica degli interessati, tra i quali figurano i nomi dei genitori di Mario Pollarolo. La data di compilazione delle due “schedine” risulta differente: quella della madre è datata 12 maggio 1944 e quella del padre 17 maggio 1944. Il testo della scheda riguardante la madre riporta con esattezza quella che era effettivamente la condizione della signora Maria Sacerdote: “Si comunica che la nominata Sacerdote Maria fu Israele, già residente in questa città, appartiene alla razza ebraica. È coniugata con ariano”, segue la firma del questore Sartoris.
Interessante risulta, invece, la scheda del padre di Mario, il signor Angelo Pollarolo; di lui si sa che non era ebreo, sia in base al racconto del figlio, sia in base al fatto che non compare negli elenchi di persone di “razza” ebraica, tanto in quello stilato dalla Questura che in quello trasmesso dal Comune alla Prefettura. Nella “schedina” invece viene segnalato come ebreo: «Si comunica che il nominato Pollarolo Angelo qui abitante è di razza ebraica, è coniugato con l’ebrea Sacerdote Maria fu Israel ed ha un figlio Pollarolo Mario pure di razza ebraica».
L’errore dipende probabilmente dal fatto che il periodo in cui vennero compilate le schede, maggio-giugno 1944, era un periodo di grande lavoro per chi dovette eseguire gli ordini impartiti dal regime. Infatti, con l’inasprimento dalla legislazione razziale, furono fatti sforzi straordinari alla ricerca di ebrei che, in qualche modo, potevano essersi nascosti.
Vi fu la sollecitazione dal governo centrale ad applicare al meglio i provvedimenti antisemiti, come l’esclusione dal lavoro e dalle scuole, il sequestro dei beni, ecc. L’intenso lavoro richiesto ai dipendenti dei comuni, delle prefetture, delle questure poteva portare a compiere degli errori: errori umani dovuti a distrazione oppure errori dovuti a chi, per paura di sbagliare ed incorrere in qualche punizione, preferiva segnalare un ebreo in più che uno in meno oppure, ancora, errori di chi, spinto da un forte spirito antisemita, svolgeva scrupolosamente il proprio lavoro di denuncia degli ebrei, includendo anche i casi dubbi.
La famiglia Segre, commercianti
La famiglia Segre era composta dal padre Aronne Aristide, dalla madre Emma Giuditta Ancona e dalla figlia Pia, viveva in via Rodi ed era una famiglia di negozianti.
Così afferma la figlia Pia: «Mio padre era un commerciante di tessuti che aveva il negozio in piazza Massimo d’Azeglio, mia mamma casalinga, io studiavo, ho un diploma di ragioniera ottenuto all’Istituto tecnico Cavour di Vercelli, siamo vissuti bene e serenamente sino al ’38, sino a quando sono iniziate le leggi razziali […] Una donna di servizio a ore che veniva ad aiutare mia mamma che era stata anche sofferente, mia mamma era già stata operata sotto le bombe a Milano… La donna di servizio è rimasta fino alla fine, saltuariamente ci aiutava».
La famiglia Cingoli Sacerdote
La storia della signora Alberta Cingoli Sacerdote porta alla luce le vicende di due famiglie: quella di origine e l’altra formata, in un secondo tempo, con il marito Alberto Sacerdote, il quale ha descritto le vicende della sua fuga con i parenti in un memorabile diario[2].
Alberta Cingoli viveva a Vercelli, in via S. Michele 5, con i genitori Augusto ed Esmeralda Bianca Bachi e due fratelli maggiori: Aldo e Vittorio. Lei stessa racconta: «Ero la terza di due fratelli, molto più anziani, perché dal primo c’era la differenza di tredici anni, dal secondo nove, e poi sono nata io nel 1916. […] Io ho fatto il liceo, ho studiato, mi trovavo benissimo insieme ai miei compagni di scuola, anche se non erano della mia religione…
[I genitori di Alberta] […] avevano un negozio di stoffa in piazza Massimo d’Azeglio. […] Eh, io ho studiato quasi fino all’ultimo; Cesare Pavese è stato mio professore a Vercelli […] Sì, sì, posso dire non avevamo problemi […], non è successo niente».
Infine, il ricordo della famiglia da parte del fratello di Alberta Cingoli, Aldo, è affidato ad un suo manoscritto nel quale scrive così: «[…] Debbo dire brevemente come era composta la mia famiglia, e come vivevamo in quel periodo.
Abitavo un vasto alloggio, al 1° piano di via Morosone 19, con mia moglie, Lydia Segre, sofferente di salute, mio figlio Franco, che allora aveva 6 anni, e mia suocera, Gemma Segre, rimasta vedova e sola l’anno prima, la quale praticamente mi dirigeva la casa. In due camere attigue all’alloggio era venuta ad abitare anche la sorella di mia suocera, Delia Segre, ved. Maroni, che allora aveva 45 anni». Aldo Cingoli era laureato in ingegneria ed era un libero professionista.
La pratica della religione ebraica
La vita di queste famiglie e di tutte le altre famiglie ebraiche vercellesi scorreva nella più assoluta normalità: il lavoro, la scuola, la rete degli amici e dei parenti, la frequenza alle funzioni religiose; le preoccupazioni, le soddisfazioni, i dolori e le gioie di tutti i giorni, come loro stessi affermano nelle interviste. Ricorda Pia segre: «Si viveva normalmente, assolutamente… Sì, una vita presa dalle preoccupazioni della nostra famiglia, mia mamma sofferente di salute, difficoltà magari di lavoro, ma, proprio personalmente, non eravamo toccati. […] Era una comunità vivace con molte persone, c’erano anche delle famiglie molto benestanti e c’erano anche dei poveri, era veramente un gruppo che offriva tutte le categorie: i poveri, i commercianti, gli intellettuali, i professori, era rappresentata da tanti elementi».
Da un punto di vista religioso si può affermare che la frequenza alle funzioni svolte al tempio non era particolarmente assidua, anche se c’era chi sentiva di più il valore del rito e quindi vi partecipava con maggior frequenza e chi invece non era particolarmente convinto e vi aderiva con minor trasporto: «I rapporti con la religione ebraica miei erano che…, prima di tutto mio padre non era un uomo religioso, quindi non ho avuto un’educazione religiosa in famiglia, però, tutto sommato, l’allora rabbino Ugo Massiach teneva dei corsi di ebraico, ci insegnava l’ebraico, pace all’anima sua, non molto bene, non l’ho mai imparato, non so più nemmeno scrivere né altro; io andavo alla sinagoga normalmente al sabato, dove c’era un banco apposito per tutti i ragazzini e le ragazzine. […] La mamma veniva in sinagoga, mio padre rarissimamente, salvo nelle grandi occasioni, proprio così, per un suo senso, diciamo così, di appartenenza più che di convinzione, mi sembra di poter ricordare. […] Noi bambini andavamo perché accompagnati dalle mamme. […] I miei parenti sono quasi tutti ebrei […] Ecco, era una comunità molto integrata, abbastanza assimilata dal punto di vista della vita. […] La circoncisione, quella è sempre stata praticata, era una cosa normalissima e sembra igienicamente ben fatta […] Sono circonciso. […] Le funzioni, ovviamente il rabbino Massiach, mi ricordo, tutte le sere andava al tempio a recitare le preghiere dovute, tutte le sere però era assistito solo dal schamasch, in genere la gente andava alla sinagoga al venerdì sera, al sabato mattina e nelle feste comandate». Così nei ricordi di Dario Colombo.
Anche gli altri intervistati sembrano confermare tali indicazioni, come Mario Pollarolo: «Sì, papà cattolico, madre ebrea, zia ebrea, naturalmente io sono stato allevato, da bambino, nell’asilo ebraico. […] Ma, con la religione, io sono sempre stato, diciamo da bambino, e da ragazzo, ho avuto degli ottimi rapporti, perché stavo a quello che mi insegnavano, poi, passando gli anni, ho incominciato a ragionare con la mia testa… [Frequentavano tutte le funzioni], sì, con la mamma e la zia».
Bisogna comunque ricordare che il padre di Mario, Angelo Pollarolo, era cattolico, anche se malgrado questo non disdegnava di frequentare la sinagoga: «Veniva anche dentro, lui non ha mai messo piede in una chiesa […] lui, se andava al funerale di un amico, andava al funerale, ma rimaneva fuori. Però veniva dentro alla sinagoga, tantoché il rabbino Massiach gli ha detto: “Lei è un ebreo onorario” […] Lui… era, diciamo, più verso gli ebrei che verso i… poi se ha sposato un’ebrea non è mica per niente… lui… siccome lui della religione poi se ne fregava nel modo più assoluto, quindi lui avrebbe sposato anche una musulmana, gli fosse piaciuta…».
Anche la testimonianza di Pia Segre concorda con quelle appena citate: «Frequentavamo le funzioni, sempre, c’era un rabbino, il rabbino Massiach, sino all’ultimo, e c’erano le funzioni al tempio, come adesso nella messa, nella funzione del sabato il rabbino diceva una preghiera, ‘Benedica sua maestà il re’, faceva parte della liturgia, coi buoni rapporti che in fondo c’erano in quei tempi e sono rimasti anche con la gente che li circondava; mio papà vendeva e aveva tanti clienti. [Tutta la sua famiglia, anche i suoi parenti frequentavano le funzioni regolarmente]. Chi era religioso sì, c’era la funzione del sabato, si andava con piacere; il venerdì sera c’erano sempre le funzioni, c’era il rabbino Massiach che fino all’ultimo è stato lì. […] Anche se nelle nostre famiglie c’è chi è più religioso e chi anche più laico, però magari, uno spirito di famiglia, per riguardo, magari, venivano lo stesso al tempio, così anche per avere occasione di fare beneficenza, per ritrovare un amico…».
Infine, Alberta Cingoli Sacerdote afferma che: «[La partecipazione alle funzioni avveniva regolarmente] perché io avevo un nonno rabbino, che era lì, poi è morto nel ’24, Isacco Giuseppe Cingoli, veniva da Urbino; mio papà andava a cantare al tempio, i miei fratelli, insomma eravamo…».
L’atteggiamento di fronte alla politica
Si è scritto fino ad ora di una vita condotta nella più assoluta normalità, come cittadini vercellesi prima di tutto. Non solo come ebrei dunque, ma come cittadini italiani con i diritti e i doveri di tutti gli altri, almeno fino al ’38; e di quella vita faceva parte a quel tempo anche la politica, naturalmente la politica del regime fascista.
Per quanto riguarda l’atteggiamento degli intervistati e delle loro famiglie, famiglie di italiani che tali si sentivano pienamente, si può affermare che non vi fosse una grande passione politica.
«Mia madre non si interessò mai molto di politica, faceva parte delle donne fasciste, naturalmente fino al 1938, partecipava, sì, a quelle riunioni che venivano fatte dalle donne fasciste, che erano, più o meno, delle riunioni mondane. Il federale Gazzotti frequentava casa mia, io parlo prima del…, mio padre andava al sabato pomeriggio alle adunate fasciste senza molta convinzione, era iscritto al Partito fascista, perché era obbligatorio, per i professionisti, di essere iscritti, io parlo sempre prima delle leggi razziali, quando eravamo, teoricamente, cittadini come gli altri, andava a queste adunate fasciste con tanto di fez e via dicendo. […] Mio padre non aveva una convinzione fascista, noi veniamo da una famiglia liberale, mio padre era e si sentiva veramente liberale.
[…] La mamma non aveva delle grandi opinioni fasciste. […] Io sono l’ex balilla Dario Colombo, appartenente alla 21a legione, questo posso dirlo, è la verità: ero balilla marinaretto, ho la tessera […], l’ho perfettamente conservata, 21a legione, venni radiato molto tardi, cioè non avevo diritto di frequentare la scuola, che d’altronde non frequentavo, perché, ribadisco, frequentavo l’asilo Levi, venivo continuamente chiamato alle adunate, persino quando ci fu la visita, non mi ricordo se nel ’41 o nel ’42, il ’41 forse, ’40, non ricordo, di Achille Starace a Vercelli, io continuai ad andare […] che erano tutti ben organizzati, i balilla marinaretti avevano l’alpenstock, il bastone da montagna, questo a dimostrazione dell’organizzazione, non potevano vincere la guerra. […] Sotto la pioggia ad aspettare Starace, davanti al Sant’Andrea, alla stazione, obbligati, come tale continuavo a vestire la divisa della gioventù del littorio. […] Solamente nel, non mi ricordo però esattamente il mese, nel ’41, venni chiamato e mi dissero che ero esentato dalle adunate, senza tante storie, senza parole offensive o senza altro. […] Io ero un ragazzo, a quell’epoca lì ero proprio un ragazzino, che opinioni potevo avere? Ribadisco il fatto che la famiglia, dalla parte di mio padre, era una famiglia altamente patriottica e risorgimentale» così afferma Dario Colombo.
Un po’ più accese sono le convinzioni di Mario Pollarolo: «Ma, diciamo che mia madre non si è mai interessata di politica se non quando la politica si è interessata di noi. […] L’unica cosa che cercava di fare era di dire a mio padre di stare calmo, perché non lo mettessero in galera, perché mio padre è sempre stato antifascista, di origini socialiste, già suo padre, lui mi diceva, del nonno, che era socialista, quindi proprio… lui è sempre stato antifascista convinto e quindi… difatti, durante il periodo clandestino, mio padre era intrigato nel Comitato di liberazione nazionale di Vercelli, con vari altri suoi amici, quindi la posizione politica di mio padre era chiarissima, diciamo che non me ne ha mai parlato esplicitamente, finché io andavo a scuola, finché tutto era tranquillo, perché non voleva creare delle cose che non andavano, diciamo, l’unica cosa che… quando io al sabato dovevo andare nei balilla, obbligato, mi vestivo da balilla per andare all’adunata, ma se lui era a casa, mi girava attorno e diceva: “Eh! È di nuovo vestito da pagliaccio”, l’unica cosa che io capivo che c’era qualcosa… poi dopo, invece, ha incominciato, poi, a esplicitarmi, mi faceva delle lezioni… Anch’io mi sono orientato da quella parte certamente; un ragazzino di quattordici anni che, da un giorno all’altro, si vede buttato fuori da scuola e via dicendo, senza capire il perché poi in fondo, allora mio padre mi ha spiegato bene come era la storia e quindi… Io andavo a scuola, finché io sono andato a scuola […] andavo all’adunata dei balilla, poi degli avanguardisti, perché ero lì a scuola, tutto funzionava bene, poi improvvisamente trac!, le leggi razziali; come facevo a diventare fascista, son diventato antifascista, da fascista, perché io ero fascista, diciamo che io ero fascista, da bambino, cresciuto in quel clima a scuola, balilla…, il libro “Moschetto, balilla perfetto” io son cresciuto… quando poi mi han dato un calcio nel sedere, allora ho incominciato a capire qualche cosa, anche se avevo solo quindici anni, e poi, come dico, mio padre mi ha istruito bene, dopo…
[…] Beh!… la tessera del partito, mio padre per andare a lavorare alla Chatillon ha preso la tessera, ha preso la tessera ma non è mai andato ad una adunata, non è mai andato ad un corteo, mai, mai, mai […] Non venivano a prenderlo, non è mai andato e nessuno è mai venuto a prenderlo».
Un quasi totale disinteresse nei confronti della politica si ha, invece, nella famiglia Segre: «Io vestivo da piccola italiana, lo devo dire, ho una foto, ho la gonna nera e ho fatto anche qualche saggio fino a livello elementare o prima media. […] Non so cosa dire, io avevo tredici anni, dodici, se andiamo indietro; era obbligatorio iscriversi al fascismo; posizione politica, non lo so, a Vercelli non è che…, c’era timore indubbiamente, si capiva che era una politica non favorevole a noi, alcuni si sono lo stesso iscritti al fascismo per poter lavorare…
[Il padre e la madre non erano interessati politicamente] No, assolutamente no, mio papà era un uomo semplice, amava la musica, sentiva la musica, ma viveva del suo commercio, leggeva molto, non c’era la televisione, sentiva la radio per avere le notizie; mia mamma si occupava della sua famiglia, assolutamente non ci occupavamo di politica».
Alberta Cingoli Sacerdote afferma che, oltre al fratello, nessuno in famiglia si interessava molto di politica: «Mio fratello Aldo faceva…, anzi mio fratello Aldo era fiduciario, era fascista della prima ora lui, perché era del ’21, era venuto fascista dal Guf, […] lui si era iscritto, e allora, vedendo che poi lavorava, gli avevano offerto era ingegnere, sempre riuscito molto bene negli studi di fare il fiduciario, che c’erano vari posti nella città, che si era fiduciario in una data zona; poi invece, con quello che è successo, tanto mio fratello, i miei due fratelli erano condannati a morte, li cercavano perché erano condannati a morte; mio fratello Vittorio, il secondo, era fascista del ’32, perché ha sempre avuto più idee, più di sinistra che non di destra, e poi invece aveva capito…, era venuto Starace una volta, era abbastanza entusiasta, poi in ultimo, poi si sentiva già, poi ci succedevan tutte queste cose qui, allora. […] Da noi non si faceva tanta politica».
Dalle leggi razziali all’8 settembre
Questa era la situazione prima del 1938, poi vi fu la svolta imposta con l’emanazione della legislazione razziale; gli ebrei dovettero incominciare a prendere coscienza del fatto che la campagna antisemita non poteva considerarsi, come per altre occasioni, una delle tante smargiassate della propaganda fascista destinate a non pesare granché sulla vita degli italiani. La campagna diffamatoria contro gli ebrei spianò il terreno a norme legislative ben precise e concrete, che erano peraltro un evidente segnale dell’alleanza tra l’Italia e la Germania e del desiderio di Mussolini di accreditarsi agli occhi di Hitler, ma, soprattutto, i provvedimenti razziali erano destinati ad incidere moralmente e materialmente con grande durezza sulle vite degli ebrei italiani.
A Vercelli, città di provincia con una Comunità ebraica di piccole dimensioni, la propaganda antisemita e la legislazione razziale fecero il loro corso senza eccezioni di sorta. Arrivarono dal Ministero dell’Interno alla Prefettura di Vercelli le circolari che sollecitavano l’applicazione dei provvedimenti razziali anche al gruppo ebraico vercellese. Gli ebrei incominciarono a risentire materialmente dei nuovi provvedimenti, soprattutto in ambito lavorativo; subirono tutte le conseguenze anche psicologiche di quanto stava accadendo, in quanto era difficile accettare l’allontanamento dal lavoro e, soprattutto da parte dei bambini e dei ragazzi, l’esclusione da scuola senza ragioni comprensibili. Inoltre, anche se non furono numerosi gli atteggiamenti apertamente antisemiti da parte della popolazione vercellese, qualche sporadico episodio vi fu; in ogni caso risultò evidente il voltafaccia della borghesia cittadina incline a seguire pedissequamente le direttive del regime.
La vita degli ebrei di Vercelli, dopo l’emanazione dei primi provvedimenti antisemiti, non fu subito radicalmente sconvolta, almeno fino all’8 settembre 1943. Naturalmente vi furono gravi cambiamenti, come l’allontanamento dal lavoro e l’espulsione da scuola dei giovani israeliti, ma tali problemi poterono essere affrontati, se non proprio risolti. Per quanto riguarda il lavoro, chi aveva un’attività commerciale poté tenere aperto, anche se in condizioni più difficili, il proprio negozio; chi invece dovette abbandonare la professione cercò, in qualche modo, di continuare a svolgerla sottobanco.
I ragazzi che furono costretti a lasciare le scuole pubbliche vennero tutti accolti all’asilo Levi dove, grazie alla disponibilità e alla generosità dell’ingegnere Giuseppe Leblis e della maestra Sansonina Gallico, poterono continuare i loro studi. L’ingegner Leblis e la maestra Gallico si dedicarono all’insegnamento dividendosi i compiti e cercando di far fronte alle esigenze dei giovani allievi iscritti, compatibilmente con le differenze connesse all’età e alle classi di provenienza. Essi dovettero impegnarsi ad organizzare l’insegnamento di tutte le materie con programmi adeguati: c’erano infatti ragazzi delle elementari, delle medie e delle superiori.
A tal proposito Dario Colombo afferma che: «Da principio c’era asilo e scuole elementari, ed era frequentato sia da ragazzi ebrei che cattolici; naturalmente, dopo le leggi razziali, solamente gli ebrei andavano in quell’asilo, perché ai cattolici era inibito andare in scuole…; lì venivano tenuti dei corsi un po’ misti, in quanto si faceva lezione sia ai bambini che facevano le elementari, sia a quelli che facevano le medie o si preparavano per gli esami, perché gli esami erano consentiti, gli esami di Stato si potevano dare, si preparavano, privatamente, quei pochi ragazzi ebrei che allora frequentavano quest’asilo che, ripeto, è stato aperto fino all’8 settembre ’43, quando sono arrivati i tedeschi, mai più riaperto dopo la guerra. […] Insegnava in quell’asilo la maestra, la professoressa Sansonina Gallico e si prestava il presidente della comunità, che era un uomo di grande cultura, era molto eclettico, ingegnere Giuseppe Leblis, il quale insegnava la matematica, il disegno e varie altre cose, sia ai ragazzini che a quelli un pochettino più adulti».
Anche la testimonianza di Pia Segre fa riferimento all’asilo Levi: “La scuola ebraica ha retto fin che ha potuto. All’asilo Levi, però, non c’erano tutti i professori per prepararci all’esame di terza media; non tutti i professori accettavano questo impegno; per matematica, credo che ci fosse l’ingegnere Giuseppe Leblis, che poi è stato deportato. […] La maestra Sansonina Gallico e l’ingegnere Giuseppe Leblis si dividevano il compito; veniva da fuori il maestro Visconti per ginnastica e un professore, non mi ricordo il nome, per canto, perché allora c’era anche canto, coi canti fascisti, quello di Roma: viva Roma libera e gioconda, io cantavo anche viva Roma”.
Quindi, dalle testimonianze raccolte, si può affermare che il gruppo ebraico vercellese poté, per un certo periodo, adattarsi senza scosse troppo drammatiche alla nuova normalità imposta dal regime; anche se questo comportò costi notevoli. Così Dario Colombo: «Le avvisaglie delle prime persecuzioni le ho avute quando sono, ovviamente, uscite, nel ’38, le prime leggi razziali; mio padre ne fu colpito in quanto, come professionista, venne radiato dall’albo, sebbene avesse diritto di essere discriminato, come consentivano allora certe deroghe alla legge per marcia su Roma, sciarpa littorio, cose che mio padre non era, ma quale ex combattente e decorato, perché ufficiale nel ’14-18.
[…] Dobbiamo sempre dividere: dal momento delle persecuzioni all’8 settembre, dall’8 settembre in poi. La condizione fino all’8 settembre era, non dico decente, perché non era affatto decente essere cittadini di serie b o di serie c, se non peggio, dopo non si era più niente, si era solo oggetto di caccia. […] Fino a quell’epoca lì, alcune leggi razziali erano severamente osservate, per esempio, inibizione al lavoro, come mio padre, non volendo essere discriminato, non ha esercitato più la sua professione. Andare nelle scuole non era possibile, c’è stato poi anche un momento in cui, quando ci allontanavamo dalla città, parlo di mio padre ovviamente, io ero un ragazzino, per un periodo che non fosse la giornata, si doveva fare la segnalazione alla Questura, per esempio, “andiamo in villeggiatura”, lo si diceva.
Inibizione ad avere la donna di servizio era nelle leggi, però nessuno ha mai fatto questioni. […] L’abbiamo sempre avuta fino, grosso modo, al ’43, quando siamo scappati. […] Quando fu proibito di avere la radio, la Questura disse: ‘Ma, ci porti una vecchia radio, dottore, e poi si tenga un’altra radio in casa’, cioè c’erano tolleranze e non tolleranze, nessun atto di violenza fisica è mai stato commesso fino al 1943, 8 settembre, cioè fino all’arrivo dei tedeschi.
[…] Bisogna spiegare cos’è la violenza morale, le leggi stesse erano una violenza morale. La buona borghesia aveva voltato la faccia agli ebrei, il popolo dissentiva mediamente e, tra questi, alcuni fascisti; per esempio, il vice federale, avvocato Radice, tuttora vivente, al cartello esposto al caffè Marchesi: ‘Qui non sono accettati gli ebrei’, rispose entrando sottobraccio a un ebreo, in pieno mezzogiorno, quando c’era la maggiore affluenza, facendo togliere il cartello, questo per dare un esempio… perché fa onore all’avvocato Radice. Vi erano alcuni antisemiti accesi, tale Inverardi, credo morto in Russia, tale Gellona, morto in Russia anche lui, i russi qualcosa di buono devono averlo fatto. C’era quel Zivelonghi, professore, che aveva pubblicato quell’articolo sul giornale ‘La provincia di Vercelli’, che era un giornale della federazione fascista, a commento della radiazione nostra dalla scuola: “Era ora che questi bambini ebrei non infettassero più le nostre scuole”. Un avvocato di Vercelli, di cui taccio il nome, anche se è morto; questo era un avvocato amico di mio padre, il quale gli voltò le spalle al punto di non salutarlo più, anche se si frequentavano abitualmente, proprio della cosiddetta buona borghesia, e che poi, alla fine della guerra, quando siamo ritornati: “Rodolfo, Rodolfo”, rivolgendosi a mio padre, “ma, perché non mi salutavi più”, e mio padre rimase talmente sorpreso da non replicare, mentre io gli gridavo: “Sputagli in faccia, papà”. […] Il fascista Bertolazzi, poi divenne capitano della brigata nera in tempi successivi, venne chiamato in federazione, perché suo figlio, che non c’è più purtroppo, era mio amico e gli dissero: “Tuo figlio frequenta un ebreo”, e lui rispose: “Mio figlio frequenta chi mi pare”, cioè reagendo in quella maniera e rimanendo sempre amico della famiglia, cui debbo anche una certa salvezza in quel di Varallo, poi in epoca successiva. […] Poi la discriminazione non era una questione di togliersi delle paure, era solo una questione lavorativa. Qualcuno lo ha fatto, perché aveva i requisiti per farlo; mio padre aveva i requisiti per farlo e forse, a differenza degli altri, aveva i mezzi per sostenersi e non ha voluto farlo per orgoglio… Però io ero un ragazzino e forse, tutto sommato, pensavo a correre in bicicletta. Mio padre chiuse definitivamente l’ufficio, continuava a fare qualche piccola consulenza, veniva ugualmente consultato fino ad un certo momento del ’43. […] Diciamo che si viveva malamente perché, per un certo periodo, le leggi si sono susseguite, quindi si apriva il giornale o si sentiva la radio sempre con apprensione per vedere quale novità venisse fuori in queste stramaledette leggi razziali, emanate da questo regime diventato improvvisamente antisemita per correre dietro ad Hitler. Io facevo una vita abbastanza riservata, avevo qualche amico, in genere continuavo ad andare, per esempio, a pattinare […] Eravamo soggetti naturalmente a tutte quelle limitazioni, per esempio, ricordo che, in occasione di una visita del duce, avvenuta in tempo di guerra, mi sembra, ci consigliarono di andare via due giorni, ma non dicendo: “Andatevene via”, “È meglio che vada via per un giorno o due”, forse perché la Questura temeva qualche cosa, pur sapendo benissimo che non era così. Facevamo una vita piuttosto riservata […] Per forza di cose, frequentando quella borghesia che, improvvisamente, si era adeguata al regime, erano stati scartati e messi un po’ all’ostracismo, quindi mio padre faceva una vita riservatissima. Nessuno ci insultava per la strada, anzi alcuni scuotevano la testa indignati».
Non troppo diverso è il racconto di Mario Pollarolo: «Ma la paura c’era, paura, si ha paura in quei momenti, specialmente dopo l’8 settembre, finché è stato così era…, perché anche lì, diciamo che le leggi razziali sono state fatte poi all’italiana, come si fa tutto in Italia, ancora adesso, molte cose eran lasciate perdere, io ho continuato a lavorare. […] Io avevo qualche agevolazione, prima dell’8 settembre, la famiglia, perché era una famiglia mista, perché c’erano le discriminazioni, c’era… tutte balle, perché da scuola mi han buttato fuori, quindi, per esempio, mi han buttato fuori, però potevo andare a fare gli esami da privatista, avessi voluto, ti mettevano in un’aula separato, da solo, perché se no impestavi gli altri, è come avere adesso l’Aids, insomma una cosa del genere… Nessun, nessun privilegio, nessun altro privilegio. Dal 1938 in avanti succede niente, perché mia madre ha continuato a lavorare, io ho continuato a lavorare, non c’è stato niente fino all’8 di settembre. […] Certamente […] c’era qualcuno che non ti salutava più, per esempio, io me ne sbattevo altamente, come tutti noi.
[Racconta l’episodio di una persona che, durante le persecuzioni, gli ha detto: «Sporco ebreo”] Un ragazzo che mi ha detto qualche cosa e io gli ho risposto per le rime: “Vieni qui che ti do due calci nel sedere e vedi dove ti mando”, non ho mai avuto paura io di quelle cose lì… Io frequentavo i luoghi di prima, andavo al cinema, al caffè, andavo con gli amici cattolici. […] Sono sempre rimasti, all’infuori di uno, due, tre, ma gli altri, io li ho sempre frequentati, loro a casa mia, io a casa loro, al caffè insieme, nessun problema.
[…] Siccome in Italia, ci son sempre state le scappatoie in tutte le cose, chi aveva, per esempio, un negozio e non poteva più averlo, la cosa era semplice, ci mettevano una testa di legno e il negozio era sempre suo: facevano finta di cedere il negozio al signor x e quello lì era lì, gli davano un tanto, diciamo uno stipendio, se vogliamo, e però il negozio era sempre dell’altro, lo sapevano tutti. [Le leggi razziali] le abbiamo accolte male evidentemente, si pensava il peggio, poi invece, diciamo, che le cose si sono un po’ aggiustate così, perché in Italia ci si arrangia sempre, come al solito…».
Ecco quanto racconta invece Pia Segre: «Mio papà si sentiva coraggioso, perché era discriminato per medaglia al valore, perché aveva fatto la guerra del ’15-18, era stato ferito, aveva la medaglia, non so se di bronzo, si sentiva tranquillo, se non che è venuto poi tutto il disordine dopo il 25 luglio e l’8 settembre 1943. […] Mio papà aveva questa medaglia, all’inizio, siccome le prime leggi erano, per esempio, che mia mamma non poteva essere aiutata da una donna di servizio, i ragazzi fuori dalla scuola, gli ebrei commercianti o chi aveva avuto però degli onori, avevano detto per la guerra ’15-18, avevano una discriminazione, cioè non so quali vantaggi, aveva però questo termine.
[La vita scorreva] normale, però ho avuto da una signorina il gesto dell’orecchio di maiale, da una mia vicina di casa, siccome sapevano che gli ebrei non mangiano il maiale. All’inizio, quando trapelavano le leggi razziali, era una mia vicina di casa, col vestito mi aveva fatto così (mostra il gesto stringendo un lembo di vestito a forma di orecchio), ecco, forse allora mi ero un pochino turbata, però avevamo tante buone amicizie, abbiamo avuto anche delle prove bellissime, la mia donna di servizio ha nascosto la roba di casa mia, ha salvato molte cose, così la padrona di casa, ci sono stati dei gesti bellissimi, ma ci sono anche stati dei gesti, per fortuna non con noi…, io non so…, facevano dello spionaggio, dicevano dove erano gli ebrei […] ma, proprio personalmente, non eravamo toccati, lo erano di più i professori e chi è stato estromesso dal lavoro e noi giovani dalla scuola, che non era piacevole, gli altri vanno alla scuola pubblica e tu no; dar l’esame da privatista non era piacevole, c’erano sempre facce, magari di professori, che sapevi che erano impegnati politicamente, molto fascisti, dovevi passarci sotto all’esame, queste cose, così, non è che ti facessero piacere, presentarti da privatista solo in tre… Eh! anche se eravamo giovani lo sentivamo questo senso di esclusione.
[…] Sono subentrate le leggi razziali, prima di tutto sono stati danneggiati i professori, la gente che lavorava nella scuola, nelle cose pubbliche, sono stati radiati fuori, i semplici commercianti, come mio papà, fino all’ultimo hanno potuto esercitare il loro lavoro. Certo, indubbiamente era una cosa che già ha turbato molto, perché ha fatto capire che anche l’Italia intraprendeva una politica diversa, il führer, gli incontri, certamente noi eravamo giovani… [Il padre non ha avuto problemi con il negozio, né gli ha cambiato nome, cosa che altri commercianti avevano fatto per mantenere aperta l’attività] No, questo a mio papà non è successo; è successa un’altra cosa, siccome, per esempio, il figlio del rabbino, che aveva dei ragazzi maschi [il rabbino], non poteva lavorare, non poteva andare a scuola, c’era l’obbligo di assumerli, mi ricordo che mio papà aveva preso come commesso il figlio del rabbino, che mi accompagnava a scuola, per dar lavoro, perché dovevano lavorare, non so bene come era questa cosa, so che mio papà aveva assunto questo ragazzo. […] A Vercelli mio papà non ha mai cambiato nome, purtroppo il negozio è stato poi devastato, hanno portato via della roba, lui ha cercato, quando le cose precipitavano, ha dato dei tessuti da tenere ai commessi.
[…] Certo, sì, ho avuto delle prove dalle mie amiche, certo, Tilde Licciardi, si può anche nominare, la moglie del professor Licciardi, siamo cresciute insieme, benché la sua famiglia fosse fascista, avesse degli impegni, eravamo in buona amicizia; altre mie compagne, vicine di casa, andavamo a pattinare alla Pro Vercelli, fino a che si è potuto, però c’era l’esclusione dalla scuola e questo, naturalmente, preclude molte amicizie, è un senso di “Tu non vieni”, c’è poco da fare. Grazie al cielo non mi è successo niente, a parte l’orecchio di maiale. […] Mio papà, io non ricordo dei gesti particolari; lui faceva una vita molto semplice, mia mamma aveva… certamente questa situazione ha fatto un po’ rinchiudere gli ebrei, indubbiamente cercavano di parlarsi di più per dire le ansie di ognuno, la preoccupazione, evitavano anche…, nel timore di avere appunto un gesto del genere, si richiudevano loro stessi di più, evitavano i contatti per non… Certo, già per istinto, gli ebrei evitavano l’ambiente borghese, per timore di avere dei gesti poco piacevoli».
Per quanto riguarda la vicenda della signora Alberta Cingoli Sacerdote bisogna segnalare che questa si sviluppa in maniera leggermente diversa dalle altre, in quanto nell’aprile del 1938 si sposò e formò con il marito una nuova famiglia, con una sua storia tutta particolare.
Ecco il suo racconto: «Ad aprile, sì, il 3 aprile, sì. Mio marito era…, aveva dei parenti a Vercelli… lui era di Pinerolo, mio marito aveva una cartoleria a Pinerolo, suo papà e sua mamma, e lui poi si era messo a lavorare nella carta, aveva la filiale della ditta Mayer, che è una ditta che produceva carta nei pressi di Milano, a Cairate, un’industria […] Immediatamente siamo venuti a Torino: in quel periodo si era abbastanza tranquilli, perché non era ancora successo niente di particolare. Alla fine del ’38 ho avuto una bambina… e si viveva un po’ a Torino, un po’ a Vercelli, un po’ a Pinerolo, perché mio marito era di Pinerolo… perché alle feste di Pasqua si andava a Vercelli, a Rosh Hashanà si andava a Vercelli, a Kippur anche. D’estate invece, dopo il mare o la montagna, si andava a Pinerolo, e così… questi anni passavano abbastanza tranquillamente.
[…] Noi, in principio, il primo anno così, tutte le feste ebraiche le passavo quasi sempre a Vercelli, tanto si stava magari un po’ di più in casa dei miei che c’erano ancora, c’era ancora mio fratello, mio papà. Poi è nata lei [indica la figlia], fine del ’38, poi mio papà è venuto ammalato, poi è morto il 31 gennaio del ’42, e poi, dopo un po’, siamo poi andati noi, noi siamo arrivati alla fine del ’42, siamo andati a stare lì, proprio, e mio marito viaggiava su e giù, perché continuava andare. […] Dunque, nel ’38 sono poi incominciate però le leggi razziali, è stato una cosa che a noi proprio non ci ha poi toccato tanto…, mio marito dipendeva da una ditta ebraica, la Vitamaier, così non abbiamo perso il posto. […] Per esempio, mia cugina, che era la mamma di questo ragionier Dario Colombo, aveva sofferto, nel senso che lei frequentava molto il circolo ricreativo, dove c’erano tutte le sue amiche e molte fasciste, insomma così, qualcuna le ha tolto il saluto, come per dire, tutte queste cose qui, ne han risentito forse di più quelli che frequentavano, io ormai ero fuori di lì, molti non della nostra religione; hanno sofferto forse questo stato così, poi non parliamo quelli che han perso il lavoro… Io mi ricordo che, prima del ’43, mio fratello Vittorio, il secondo, che era avvocato, non ha più potuto andare a lavorare; lavorava lo stesso, faceva le conclusionali, però non poteva andare in tribunale. [Manifestazioni di razzismo] dirette proprio niente, dirette niente, non le abbiamo avute… anzi, io ho lasciato degli scritti, delle cose per quello che ci hanno aiutato, molte persone, perché han dovuto nasconderci qui. […] Una volta mio marito mi raccontava di questo, ma quando era ancora a Pinerolo, che gli ha fatto tanto effetto, di uno che gli ha fatto così [mostra il gesto con il vestito] come per dire le orecchie…, io quello non sapevo nemmeno che si potesse fare».
[A questo punto dell’intervista interviene la figlia, nda] «Per quel che ne so, da quel che mi ha raccontato la mamma, non è che loro avessero delle grandi frequentazioni sociali, era una famiglia piuttosto… si frequentavano tra parenti, quindi non hanno avuto tanto occasione di avere degli scontri».
[Riprende Alberta, nda] «Eh, siamo vissuti normalmente, mia mamma andava in negozio, mio fratello faceva quel lavoro, scriveva in casa quello che poi portava lì nello studio».
Aldo Cingoli, per parte sua, presenta così la sua situazione: «Rispetto alle leggi razziali del 1938 io ero un ebreo ‘discriminato’ e godevo di parecchie agevolazioni. Potevo tenere la radio; potevo tenere lo studio professionale, e non ero costretto ai lavori manuali; potevo tenere personale di servizio ‘ariano’. Perciò avevo in casa con noi una anziana donna di servizio, affezionata alla mia famiglia […]. Nonostante questi ‘vantaggi’ dovevo però anch’io denunciare sempre in questura i movimenti miei e della mia famiglia. Avevo inoltre dovuto trasformare la mia ditta in anonima per poter assumere lavori, ed estromettermi dalla sua direzione, limitandomi ad una consulenza professionale».
Ma i giorni, i mesi, gli anni passavano e le condizioni degli ebrei, con l’entrata in guerra dell’Italia e l’inasprimento della legislazione razziale, peggioravano. Con il passare del tempo vivere a Vercelli diventava insostenibile; oltre all’isolamento sempre più marcato dal resto della popolazione, era effettivamente sempre più reale il pericolo di essere catturati e deportati. Anche gli ebrei di Vercelli, come tutti gli ebrei in Italia, vissero il dramma della deportazione, della paura dell’arresto, dell’espatrio e della clandestinità; vi furono manifestazioni di solidarietà, ma anche casi di delazioni, segnalazioni anonime, razzismo.
Con la dichiarazione di guerra, il 10 giugno del 1940, la condizione del gruppo ebraico vercellese peggiorò per due motivi: gli ebrei, come il resto degli italiani, con il paese in guerra dovettero affrontare notevoli disagi; inoltre la loro condizione di ebrei si fece tanto più grave a causa dell’inasprirsi della legislazione razziale dovuto al profilarsi dei nuovi avvenimenti. Molti ebrei italiani e vercellesi presero coscienza di tale situazione.
Significativa è la testimonianza di Dario Colombo: «Il 10 giugno del ’40 fu la dichiarazione di guerra e io abitavo in piazza Massimo d’Azeglio che è proprio vicinissima a Palazzo Littorio, che era allora la federazione fascista, dove c’erano tutti gli altoparlanti; la piazza era tutta gremita da gente, fascisti, non fascisti, per ascoltare quel famoso discorso di Mussolini che annunciava la dichiarazione di guerra alla Francia e all’Inghilterra. Quando poi si sciolse questa manifestazione, questo lo ricordo perfettamente, perché allora avevo dieci anni, poco più, dieci anni e mezzo, mio padre mi prese per mano, aprì la finestra del balcone, che avevamo prudenzialmente tenuto chiusa, e prendendomi per mano mi portò sul balcone e mi disse: “Vedi, figliolo mio, di qui passeranno i soldati inglesi”, e fu questo il primo commento che mio padre fece di tutta la situazione con suo figlio».
Rimase agli ebrei italiani un’unica speranza: un solo fatto poteva essere in grado di restituire loro i diritti negati e la libertà che a poco a poco stavano perdendo; questo fatto, tanto desiderato, si realizzò il 25 luglio del 1943 e fu la caduta del fascismo. Un avvenimento questo che venne accolto con grande entusiasmo da tutti gli italiani antifascisti, soprattutto dagli ebrei; per loro significava la fine della tanto assurda, tanto temuta e tanto odiata legislazione razziale. Nello stesso tempo gli entusiasmi celavano molta preoccupazione per un destino ancora incerto per gli italiani in generale e per gli ebrei in particolare; e la storia avrebbe poi dimostrato che quelle preoccupazioni non erano infondate.
Ecco, nel ricordo degli intervistati, come viene descritta la caduta del fascismo: «Me lo ricordo perfettamente il 25 luglio 1943. […] La tensione, ma questa la sentivamo tutti in quel momento lì, il 25 luglio le leggi razziali non furono abolite, però nessuno disse più niente, fino a quando venne firmato l’armistizio e la Cassibile da parte di Castellani, inviato da Badoglio, nelle cui clausole c’era l’abolizione delle persecuzioni; non ci sono state persecuzioni, dal punto di vista incombente, da parte dei badogliani, ma non c’è stata nemmeno l’abrogazione, benché [sic] ne dicano i seguaci di Badoglio. […] Sì, c’è stata una reazione di gioia, ma anche, da parte di mio padre, ricordo perfettamente, una consapevole preoccupazione di quello che avrebbero potuto fare i tedeschi. Mio padre era un uomo abbastanza intelligente e colto e aveva avuto la percezione che l’Italia non si sarebbe districata tanto facilmente dai tedeschi, se non arrivavano gli Alleati in fretta e furia. […] Certamente eravamo ben contenti che fosse caduto questo regime che ci aveva perseguitati; a Vercelli c’è stata qualche sporadica manifestazione antifascista, molti fascisti buttarono i distintivi, la famosa cimice, come si chiamava allora, bianca, rossa e verde con l’Italia e il fascio in mezzo, nella fontana che c’è davanti alla stazione. Insomma, un certo sollievo misto a preoccupazione per quello che avrebbe potuto capitare»; questo il ricordo di Dario Colombo.
Mario Pollarolo racconta invece un episodio che visse in prima persona: «Ah!, quando è caduto il fascismo, a Vercelli, la via della sinagoga si chiamava via Foa, e quando sono nate le leggi razziali, sopra la targa via Foa han messo una targa, 17 novembre 1938, allora il ragazzino [riferendosi a se medesimo], a quell’epoca, ha preso una scala e, nonostante le proteste dei carabinieri che non so poi perché, cosa avevano da protestare, perché la gente poi non era d’accordo con i carabinieri, ma era d’accordo con me ha tolto le targhe e sotto è ricomparsa via Foa, quando è caduto il fascismo, ho fatto anche quella io. Tra di noi l’abbiamo festeggiato certamente… invece è incominciato il peggio».
La medesima sensazione di gioia seguita da paura si può individuare anche nelle altre testimonianze, come quella di Pia Segre: «La gioia esplosiva, una grande felicità, un’illusione, il 25 luglio è caduto il duce, gioia in famiglia, ubriachezza, tutto finito, c’è Badoglio, tutto bene, un’allegria spaventosa. […] È durata non so se ventiquattro ore l’illusione, si è subito visto che arrivavano peggio di prima i tedeschi, che il re scappava, è durata, sì e no, penso poche ore l’illusione. […] Molta preoccupazione, molta preoccupazione […] mio papà non comprava più per il negozio, non sapeva cosa fare nel lavoro, si seguiva con molta angoscia, mai più immaginando che arrivavano i camion dei tedeschi a Vercelli […] era un fuggi fuggi, chi poteva andava all’estero… Per esempio c’era l’idea, siccome c’erano i bombardamenti, è iniziata la mentalità dello sfollamento, per cui molte famiglie, anche queste signorine Foa, che la sorella era segretaria di Farinacci, sfollavano, sfollavano in Valsesia…».
Anche Alberta Cingoli Sacerdote ricorda la caduta del fascismo come un momento di paura più che di gioia. In quel periodo si trovava a Vercelli con il marito, la figlia e il figlio nato da poco tempo e ricorda: «Eravamo lì a Vercelli, io, mio marito, il bambino e la bambina Franca, quando il 25 luglio, eran le undici, mio fratello Vittorio era uscito, viene a casa entusiasta, ci sveglia e dice: “Hanno buttato giù Mussolini”, chissà perché tutti erano felici e contenti, io dico: “Cosa? Io ho paura”, perché capivo che, sentivo che non poteva finir tutto tranquillamente così e basta, io sentivo che sarebbe stata una cosa un po’… preoccupante, e difatti è proprio stata una tragedia, perché io credo che se Mussolini fosse rimasto, forse non succedeva questa enorme cosa dei nazisti che… E difatti si tira avanti ancora due mesi, io tranquillamente andavo ai giardini coi bambini, mi trovavo… andavamo qualche volta perfino a fare i bagni alla Sesia. Insomma era tutto tranquillo quando… succede poi l’armistizio e… e allora arriva il famoso 8 settembre con l’armistizio, con gli Alleati e allora i tedeschi non sono più i nostri alleati, ma da alleati diventano quasi padroni».
Quel breve periodo di sollievo fu immediatamente seguito da angoscia e preoccupazione per un futuro pieno di incognite, soprattutto per gli ebrei; dalle interviste è emersa pienamente la loro consapevolezza di quanto si stava preparando.
Con l’arrivo dei tedeschi in città, infatti, le cose peggiorarono. Ben presto l’ansia ed il terrore divennero gli unici stati d’animo di ogni ebreo vercellese. I pensieri di ogni giorno erano tutti concentrati sul da farsi: restare nella propria città, nelle proprie case, sperando che tutto si sarebbe risolto per il meglio e che le prime voci che giungevano a proposito dei campi di concentramento e degli eccidi di ebrei in Europa fossero esagerazioni infondate; oppure fuggire, lasciare tutto: la città, la casa, il lavoro, i parenti, dirigersi lontano senza una meta precisa, andare incontro all’incertezza. E se questa fosse stata la soluzione errata e la più rischiosa, visto il pericolo di arresti lungo il tragitto? Se rimanere tranquilli nelle proprie case, dimostrando di essere buoni cittadini italiani fosse stata la scelta migliore? Tali dubbi attanagliavano la mente di tutti, tanto più che era ben poco il tempo a disposizione per decidere il futuro della propria vita.
Un simile stato d’animo emerge chiaramente dalle affermazioni di Pia Segre: «C’era la mentalità di incominciare a pensarci, ma mia mamma e mio papà lo rifiutavano fino in fondo, si illudevano, si sono illusi fino a che questa mia zia ci ha imposto di scappare: adesso per noi è il senno di poi, ma allora, allora c’era gente che pensava: “Lascio tutto il mio lavoro? Dove vado? Cosa faccio?”, era un salto nel buio per della gente semplice, per chi non aveva possibilità, era andare nelle montagne, con quali soldi? Pagare affitti? Non era semplice».
Sentimenti non molto diversi si rilevano nella testimonianza scritta di Aldo Cingoli: «Nell’estate del 1943, con regolare denuncia in Questura, avevo portato la mia famiglia in val Cervo, e precisamente a Quittengo […]. Passati i mesi estivi avremmo dovuto ritornare tutti a Vercelli. Ma gli eventi politici erano tutt’altro che rassicuranti. E poiché Quittengo era un paese tranquillo, dove tutti ci erano amici, avevamo rimandato il ritorno. Alcuni miei parenti, come mio cognato Giorgio Segre, avevano senz’altro abbandonato l’Italia, rifugiandosi in Svizzera, e mi scrivevano di seguirli. Le notizie circa il progredire dell’occupazione tedesca erano pessime. Raccontavano i fatti di Meina[3], ma non sembravano cose credibili. Io non intendevo assolutamente lasciare l’Italia, e non potevo credere a quelle assurde atrocità, che, purtroppo, invece erano vere.
Così passò l’estate, e venne il settembre. Per ragioni di lavoro, pur lasciando la famiglia a Quittengo, io dovetti ritornare a Vercelli».
I tedeschi a Vercelli
Tale clima di incertezza mista a preoccupazione peggiorò con l’arrivo dei tedeschi sul suolo vercellese. Essi giunsero tra l’inizio e la fine del settembre 1943 e la loro venuta aggravò drammaticamente le condizioni del piccolo gruppo ebraico.
Con i tedeschi presenti in città il rischio di arresti e deportazioni era sempre più reale; gli israeliti erano ormai braccati in tutta Italia e lo furono anche a Vercelli, dove, con l’aiuto delle forze dell’ordine cittadine, i tedeschi poterono individuare tutti gli ebrei residenti in città e riuscirono anche ad arrestarne e deportarne alcuni.
Sgomento, terrore e incertezza furono gli atteggiamenti prevalenti di fronte ai primi tedeschi che entrarono in città. Tutti gli intervistati hanno chiaro nella memoria il ricordo di quel giorno, vissuto da ognuno in modo diverso.
Dario Colombo era ancora un ragazzino e quel giorno girava solo per la città mentre tornava da una lezione scolastica; c’era il mercato e nitida è la sua descrizione della confusione provocata dalla gente che scappava più che dalle bancarelle sparse per la via. L’incoscienza dovuta alla giovane età lo portò a girare per le vie cittadine alla ricerca del perché di tanto disordine: «Ero solo, andai verso Porta Milano, che trovai completamente deserta, e mi avvicinai all’edificio del gas, stupito di non vedere proprio più anima viva; lì, dietro l’edificio del gas, venne fuori un soldato tedesco che mi fece: ‘Psss, psss’, si vede che voleva avere qualche notizia, io naturalmente, vedendo una divisa tedesca, ho detto: “Altro che inglesi”, girai le spalle e me ne andai tranquillamente, cioè un po’ di corsa per dir la verità, fino all’Olmia, dove mio padre era stato precettato e dove lavoravano tutti tranquillamente, per dare la notizia che erano entrati i tedeschi».
Accompagnato dal padre, che lasciò immediatamente il lavoro, si diresse verso il distretto militare, dove passavano gli autocarri tedeschi; il padre di Dario chiese ad un carrista, fuori dalla torretta, dove fossero diretti gli autocarri e questi rispose: «In Francia». «Mio padre rimase ancora un certo momento lì, fino quando vide che tre o quattro di questi carri armati si assestavano dove c’era allora il campo della fiera, antistante alla caserma… puntando i cannoni verso la caserma, allora mio padre disse: “Andiamo via, perché questi in Francia ci andranno, ma in parte, gli altri si fermeranno qui”; allora abbiamo compreso che la città era stata occupata dai tedeschi, cioè stava per essere occupata dai tedeschi».
Mario Pollarolo invece durante l’occupazione tedesca della città si trovava al lavoro con la mamma alla ditta Cantoni; furono avvertiti dell’arrivo dei tedeschi da una telefonata anonima: «Ah!, non si sa, c’è stata una telefonata in ditta, di una voce femminile che ha detto: “State attenti, perché sono in cerca”, non so chi ha telefonato, no».
Anche dal manoscritto di Aldo Cingoli sappiamo che il giorno dell’arrivo dei tedeschi a Vercelli era un giorno di mercato; lo stesso Aldo si trovava in piazza Zumaglini piena di gente venuta dal contado:«Ad un tratto corse la voce:”Arrivano i tedeschi!! ” e la piazza in pochi minuti si svuotò. Tutti fuggirono ed io rimasi solo, nella piazza deserta, in una Vercelli deserta ed impaurita, e mi chiedevo il perché: arrivavano i tedeschi! Era da giorni che si aspettavano, ma non avrebbero mica ammazzato tutti».
Da quel momento in poi il destino degli ebrei vercellesi divenne per certi versi simile; se prima, con la legislazione razziale, le loro vite non avevano subito cambiamenti troppo radicali, adesso arresti e deportazioni erano una realtà vera a portata di mano. Si prospettavano a quel punto due sole soluzioni possibili: fuggire o rimanere; entrambe erano molto rischiose. Alcuni ebrei non si trovavano più in città e avevano già fatto la loro scelta di fuga. A coloro invece che ancora si trovavano in città l’arrivo dei tedeschi impose di prendere rapidamente una decisione. Quelli che rimasero ebbero sorti molto diverse: vi fu chi venne arrestato e deportato, chi invece continuò a vivere nelle proprie case; il perché è senza risposta, per molti fu solo il caso a decidere, per altri contarono le contraddizioni insite nella legislazione razziale.
Chi fuggì, partì per un destino incerto, quasi alla cieca, non sempre con una meta precisa e sicura. La fuga e l’abbandono della propria città, significò l’abbandono di tutto; le storie divennero «storie di singole esistenze in fuga, esperienza di individuo o al massimo di piccolo gruppo, spesso piccolissimo gruppo: la sensazione di solitudine non è più solo idea che si fa strada “lentamente, confusamente”, è certezza scandita dai nomi, ogni volta più numerosi, di quanti, arrestati, sono scomparsi»[4].
Ma anche nella solitudine dei piccoli gruppi famigliari le strategie di fuga furono simili tra loro; molti ebrei puntarono verso la Svizzera; altri verso le dimore di parenti non ebrei, cercando una nuova forma di esistenza con tanto di false identità; altri ancora puntarono verso le montagne, cercando rifugio nei piccoli villaggi o nelle baite isolate.
I racconti degli intervistati, riguardo alla fuga e alla nuova sistemazione, si sviluppano diffusamente, sono carichi di ricordi chiari o con poche incertezze. Considerando le vicende delle cinque famiglie studiate si può notare come tutte fuggirono nei giorni appena successivi all’arrivo dei tedeschi, ma verso mete diverse.
La famiglia di Dario Colombo partì con quella di Pia Segre i due sono cugini tra il 10 e il 13 di settembre. Tra le due famiglie i più decisi furono i Colombo; i Segre infatti erano assai più titubanti. Ecco quanto emerge dal racconto di Pia Segre: «Mio papà si è illuso fino all’ultimo, viveva nella cotonina con mia mamma; in fondo noi dobbiamo la salvezza alla mamma di Dario Colombo, perché molto più perspicace di noi, leggeva e sentiva. Mia mamma non sarebbe scappata…, diceva: ‘Ma no, non abbiamo fatto niente, non succede niente in Italia, non succede niente’, anche mio papà. La mamma di Dario è venuta da mia mamma in ginocchio e ha detto: ‘Io non scappo se non venite anche voi con me, tu non hai idea, io so già in Germania, cosa è successo’; siamo poi scappati il 13 settembre».
Con loro fuggì anche l’altra sorella di Elvira ed Emma Giuditta Ancona, Tatiana, con la figlia piccola. Si diressero alla stazione, piena di tedeschi che, per fortuna, non si erano ancora organizzati per i controlli e gli arresti e, quindi, non li fermarono; la loro destinazione fu Varallo. Qui affittarono insieme alcune stanze nella casa di un ferroviere e, dopo poco tempo, le loro strade si divisero. Tatiana Ancona andò con la figlioletta nel Bergamasco, precisamente ad Antegnate, in un cascinale, dove «è vissuta di polenta, però si è salvata vivendo in un paesino del Bergamasco».
Sempre a Varallo i Colombo e i Segre entrarono in contatto con un prete, don Gianni Nascimbene, che li aiutò ad ottenere i documenti falsi. I Colombo avevano compiuto un primo trasferimento a Dovesio, sopra Varallo, perché rimanere tutti uniti nella casa del ferroviere stava diventando pericoloso. Poi essi fuggirono in Svizzera, ma senza i Segre. Ricorda Pia: «Mio papà aveva paura, diceva: “Lei è appena stata operata [la moglie], soffre di cuore, io non ho il coraggio di far questo passo, io non so…”. Aveva delle titubanze, c’era il confabulare tra le due sorelle e i due cognati, c’era un’armonia meravigliosa, loro hanno organizzato il viaggio in Svizzera».
Il padre di Dario invece contattò alcuni contrabbandieri che, dietro lauti compensi, organizzarono la fuga in Svizzera. Ecco quanto ricorda Dario Colombo: «Con una marcia di diciassette o diciotto chilometri che è avvenuta in, grosso modo, sei ore […] abbiamo passato la frontiera, dopo aver fatto un varco nella rete metallica, con l’arrivo dei tedeschi e sparatoria da parte dei contrabbandieri e dei soldati alleati. […] Siamo entrati tutti attraverso questo buco, anche i contrabbandieri, perché non hanno più osato tornare indietro, e ci siamo presentati […] in località Stabbio alla gendarmeria cantonale svizzera…». Da quel momento iniziò il pellegrinaggio in diversi campi di raccolta svizzeri, fino a quando Dario non venne separato dai genitori per essere trasferito in un collegio per ragazzi e, dopo ancora, affidato ad una famiglia svizzera fino alla fine della guerra.
La famiglia Segre invece trovò rifugio e salvezza nel capoluogo piemontese; il padre di Pia aveva, infatti, un cognato non ebreo, marito di sua sorella, il quale era direttore a Torino del Banco di Sicilia. Egli venne contattato da don Gianni Nascimbene, che faticò non poco, vista la pericolosità dei tempi, a far ammettere al direttore del Banco di essere parente dei Segre. Così, dopo una tappa a Santena e pericoli corsi durante un rastrellamento nella zona, i Segre si trasferirono definitivamente a Torino fino alla fine della guerra.
Chi lì aiutò a sopravvivere sotto falso nome fu un cassiere, sempre del Banco di Sicilia, il siciliano Giuseppe Greco, che visse con loro nella stessa casa: «E abbiamo iniziato a vivere in via Casteggio 15 a Torino con questo siciliano, che ha adorato mio papà e mia mamma, mia mamma gli aggiustava le calze, gli faceva da mangiare… Io facevo le commissioni, ero l’unica che potevo uscire e prendevo il tram, tutta contenta, in mezzo ai tedeschi, non avevo paura e andavo in banca, sopra c’era mio zio, ma non dicevo niente, io dicevo che ero la cugina del dottor Greco e mi davano delle cose schifose, lo ricorderò sempre, una conserva pressata per fare il condimento, del pane di riso durissimo, nero… La fine della guerra ci ha sorpresi il 25 aprile a Torino…».
Quanto a Mario Pollarolo, ai genitori e alla zia materna, dopo la notizia dell’arrivo dei tedeschi, essi si nascosero qualche giorno a Vercelli in casa di parenti, poi lasciarono la città trasferendosi in varie località della Valsesia. Il padre, in quanto non ebreo, dopo pochi giorni, ritornò a Vercelli per recarsi al lavoro e, stando al ricordo di Mario, nessuno gli fece domande sulla scomparsa dalla città della sua famiglia.
A questo punto la vicenda di Mario Pollarolo assume un aspetto diverso da quella degli altri intervistati: Mario venne infatti catturato e riportato a Vercelli al distretto militare; il padre ritornò in Valsesia a riprendere la moglie e la cognata, che rientrarono a Vercelli e continuarono a vivere tranquillamente in città fino alla fine della guerra, affrontando senza danni anche un rastrellamento; i tedeschi non seppero mai della loro appartenenza alla “razza” ebraica. Mario invece riuscì a scappare dal distretto militare aiutato da un ufficiale dell’esercito di cui non avrebbe mai saputo il nome.
Egli così racconta: «Allora non sono andato a casa, sono scappato da un mio zio, perché a casa non mi fidavo andare, ho fatto avvisare mio padre, poi mio padre è venuto a prendermi e li è incominciata l’avventura; ho fatto delle cose che facevano tutti allora.
[…] Sono andato a Torino, poi sono andato in valle Varaita e ho fatto tutta la guerra lì». Mario diventò poi partigiano, con il nome di battaglia di “Leopardo”.
La storia di Aldo Cingoli è narrata nel suo manoscritto dal quale si apprende come fosse solo a Vercelli il giorno dell’arrivo dei tedeschi. La sua famiglia era in vacanza a Quittengo e con lui era tornata in città solo la zia della moglie, Delia Segre Maroni; ma leggiamo le sue parole: «Io, ingenuamente, mi sentivo tranquillo e con le carte in regola. Ad ogni modo tornai a casa, e decisi di partire subito per Quittengo, per essere vicino alla famiglia. Dissi alla zia di venire via con me, e chiudere la casa, perché intanto a Vercelli non si poteva fare niente. La zia rifiutò: mi disse: “Va tu a Quittengo; io resto qui a custodirti la casa”. Alle mie insistenze perché venisse via con me rispose: “Cosa vuoi che facciano ad una vecchia sola! E poi so spiegarmi bene, anche in tedesco”. E questo suo voler restare a Vercelli le è costato la vita, e terribili sofferenze. Ed io sono rimasto con il rimorso ed il rammarico di non essermi imposto per portarla via; con il rimorso di non aver capito neanch’io la gravità del momento, e le atrocità dei tedeschi». In queste poche parole sono racchiuse tutte le sensazioni, tutti gli stati d’animo degli ebrei di fronte alla persecuzione antiebraica e alla crudeltà tedesca.
Aldo tornò successivamente a Quittengo, ma anche quella località non era più sicura; ricevette infatti una telefonata da un amico: «…”Non tornare a casa, perché non hai più casa. La tua casa è stata occupata dai tedeschi”, “E la zia che era in casa?”, “È stata arrestata e portata alle carceri del Castello. Anche tu e la tua famiglia siete ricercati. Non fatevi trovare!!”…». Così anche per Aldo Cingoli e la sua famiglia iniziò il calvario della fuga in diverse località del Biellese: Biella, Candelo, Bioglio, Mucengo. In quel periodo egli ebbe anche un incontro con i tedeschi ma, grazie ai documenti falsi, si salvò. L’ultima tappa del percorso di fuga di Aldo Cingoli e della sua famiglia fu la Svizzera; il soggiorno oltre confine durò dal 17 febbraio 1944 alla fine della guerra.
Rimane infine la vicenda della signora Alberta Cingoli Sacerdote che, quando arrivarono i tedeschi a Vercelli, si trovava in città con il marito Alberto, i due figli, Franca e Sergio, e la madre Bianca. Ecco, dal suo racconto, quale fu la sua prima decisione: «Quindi che cosa facciamo? Era molto… eravamo lì con tutta ’sta famiglia, con i bambini, mia mamma che era vedova, i miei due fratelli, uno aveva un figlio ed era sposato, l’altro aveva solo una fidanzata che non poteva sposare, perché non ebrea. E allora era pericoloso…, mentre mio fratello, il secondo, cerca di andare a Roma… Ecco mio fratello è andato lì, il secondo. Invece il primo era in villeggiatura già a Quittengo, nel Biellese, era lì e stavano quasi per tornare, perché era settembre, invece han pensato di starsene là e non tornare nelle loro case.
Allora noi, raccogliendo tutto quel che pensavamo poteva servire, perché non si sapeva quando si sarebbe ritornati, in fretta e furia, in due giorni andiamo a Quittengo anche noi per decidere che cosa fare».
Da Quittengo i Cingoli contattarono varie persone alla ricerca di un possibile rifugio; vennero così accolti da alcuni parenti ad Acqui; questa non fu però la sistemazione definitiva, ne seguirono delle altre. Da Acqui infatti si trasferirono poi a Buronzo, a Torino, a Bioglio, ecc.; tutto questo in funzione della grande partenza per la Svizzera, incoraggiati dal fratello di Alberta, Aldo Cingoli. Da Bioglio in avanti le varie fasi del viaggio in direzione della Svizzera, con tutti i disagi e le sofferenze che esso comportò, sono state raccontate di getto da Alberta, ma, soprattutto, magistralmente descritte dal marito, Alberto Sacerdote, in un diario che avrebbe sempre tenuto nascosto alla sua famiglia e che la moglie avrebbe ritrovato solo alla morte del marito.
Il diario inizia così: «Esodo, 1944. Perché Franca e Sergio possano ricordare uno dei più tragici momenti della vita di mamma e papà, vissuto insieme con loro e la nonna Bianca quando essi non avevano che 5 anni e 9 mesi.
Perché imparino ad essere forti, calmi e buoni.
Perché abbiano eterna riconoscenza per la nazione svizzera».
Il diario racconta della fuga in Svizzera: «Il 15 febbraio 1944 tutti noi siamo diventati ospiti della generosa nazione Svizzera”. Ma la tormentosa vicenda della fuga non si interruppe con il passaggio oltre confine. I vari membri della famiglia vennero trasferiti in diverse località e in diversi campi di internamento per rifugiati; in particolare a Mudon i Sacerdote vissero l’ultimo atto della loro tragedia: in quel campo morì il figlio, il piccolo Sergio.
Il bambino infatti si era ammalato, ma le sue gravi condizioni non erano state valutate con serietà dai medici, che avevano minimizzato la malattia: “Lui, il bambino, stava bene, incominciava a mettere i denti, prendeva ancora solo il latte e farina lattea…, mancava il medico dei bambini e c’era un medico, che insomma non ha capito niente… diceva: “Ma no, che sta bene”, non mangiava e diceva: “Sono i denti’” insomma tutto così, passa un giorno, passa l’altro, passa l’altro ancora e poi il bambino non mangiava…».
Dopo quel fatto drammatico la famiglia Sacerdote venne poi trasferita ancora un paio di volte: nel campo di Finhaut, Valais e dopo ancora a Weggis, dove rimase fino al 13 luglio 1945.
La Comunità ebraica dopo il 1945
La fine della guerra colse i protagonisti delle storie narrate nelle località in cui si erano rifugiati. Il dolore e la sofferenza subiti furono tali da determinare in loro una grande voglia di riscattarsi, ritornando a Vercelli il più presto possibile e riprendendo le loro vite di sempre, bruscamente interrotte dalle persecuzioni. Tuttavia tra il ritorno a Vercelli, che avvenne quasi per tutti nell’estate del 1945, e la sistemazione definitiva in città trascorse un lasso di tempo, a causa dei cambiamenti causati dalla legislazione razziale e dalla guerra, soprattutto per quanto concerneva il lavoro, le proprietà e le case.
La casa costituì uno dei problemi principali, in quanto gli ebrei italiani in generale e vercellesi in particolare, fuggiti o arrestati, erano stati privati delle loro abitazioni. La famiglia di Dario Colombo, ad esempio, al rientro a Vercelli, nel luglio del 1945, dovette cercare una sistemazione temporanea poiché la casa era momentaneamente occupata: «Prima siamo stati nella casa di Aronne Aristide Segre che ci ha ospitati, perché la nostra casa era occupata dal dottor Salamano, che era stato sfrattato dai tedeschi e in attesa di poter rientrare nella sua casa, che era stata a sua volta presa dagli inglesi, abbiamo dovuto aspettare un mese o un mese e mezzo, e poi siamo rientrati nella nostra casa».
L’intera famiglia Segre tornò a Vercelli in maggio, ma il padre di Pia aveva già preceduto la moglie e la figlia in città per un sopralluogo: «La storia è anche lì bella; a Vercelli, intanto, il suo negozio era tutto depredato, c’era il magazzino, nella nostra casa viveva una famiglia, perché dove abitavano loro i tedeschi avevano fatto il comando, per cui tutti quelli che abitavano nelle loro case li hanno messi nelle case degli ebrei. Mio papà è tornato a vedere come stavano le cose, al più presto possibile ha portato anche noi e non avendo casa siamo andati a dormire dalla donna di servizio che avevamo, Esperia Sarasso, che è ancora viva a Novara, che ci ha aiutati, aveva una casetta in via Giovenone a Vercelli […]. C’eran tutti gli americani a Vercelli […], era occupata da tutta questa gente e dagli inglesi che avevano occupato dove c’era il comando tedesco; intanto la signora che abitava a casa nostra diceva: “Io non posso tornare a casa mia, per cui non posso ridarle la casa”; erano marito, moglie e la figlia, una bella signorina, gente che conoscevamo, e mio papà sbuffava, andava dagli inglesi: “Io devo riavere la mia casa”, e dormivamo da questa donna di servizio». Trascorso il tempo necessario a risolvere la delicata situazione, anche i Segre poterono ritornare in possesso della loro casa.
Alberta Cingoli Sacerdote tornò a Vercelli il 13 luglio 1945, con il marito, la figlia e la madre: «Siamo stati ancora a Vercelli fino a quando si è sposato mio fratello; come è tornato, mio fratello Vittorio, ha voluto subito sposarsi, difatti il 29 luglio si è sposato, e allora siamo andati a Pinerolo».
Mario Pollarolo, invece, non dovette affrontare il problema della casa occupata da altri, in quanto, come già indicato precedentemente, nella sua casa avevano continuato ad abitare, in piena guerra, il padre, la madre e la zia.
Gli ebrei vercellesi, ristabilitisi in città dopo la guerra, ripresero le loro consuete abitudini: gli adulti il lavoro e i ragazzi la scuola. Nell’insieme il reinserimento nella società vercellese fu buono, senza particolari disagi, né particolari manifestazioni di antisemitismo da parte di chi non aveva del tutto messo a tacere il proprio odio razziale. Solo Dario Colombo ha ricordato un episodio, una lite che si svolse così: «Ci fu uno, mi ricordo che ero con Tedeschi, ex ufficiale dell’aviazione, Alberto Tedeschi, […] eravamo al caffè Marchesi e uno disse: ‘Potevano ammazzarli tutti questi ebrei’, finimmo in Questura, perché l’abbiamo buttato dalle scale e si è spaccato una gamba. Tedeschi avrà avuto ventisei, ventisette anni e io ne avevo sedici, ma eravamo talmente furenti… non ci fecero niente, si riparò la gamba da solo».
Il padre di Dario riaprì l’ufficio in poco tempo: «Riapre l’ufficio; sì, subito, insomma reinserendosi, poi correvano tutti in quel momento lì, tutti lo salutavano: “Caro dottore” […] La mamma, mia mamma è sempre stata casalinga».
Per Dario ricominciò la scuola, sostenne gli esami insieme ad altri ragazzi ebrei per recuperare gli anni perduti a causa della guerra e della fuga dovuta alle persecuzioni razziali; gli esami furono agevolati da quella che venne chiamata la “sessione partigiana”: «Venni naturalmente promosso, perché le risposte che noi davamo alle interrogazioni erano di questo tipo, arrivava un tale e diceva: “Lei di cosa vuole parlarmi?”, “Di ventidue mesi di montagna come partigiano”, “Promosso”, “Lei di cosa mi parla?”, “Di venti mesi di internamento in Svizzera”, “Promosso”, cioè eravamo promossi tutti, poi le difficoltà sono venute dopo, perché io non sapevo niente». Si diplomò poi in ragioneria.
Anche per Mario Pollarolo il reinserimento avvenne in una relativa normalità: «Ma, il reinserimento… son tornato a lavorare tranquillamente, come niente fosse, sempre lì, poi me ne sono andato all’estero. […] I genitori son rimasti qui».
Il padre di Pia Segre, invece, era molto ansioso di rientrare in possesso dei propri beni e di riaprire il suo negozio di stoffe; questo lo portò più volte a recarsi al comando inglese, per reclamare i propri diritti: «Mio papà andava lì e vedeva tutta la sua roba, i banchi, i mobili, tutto e diceva: “Ma io questa roba devo prenderla”, e portava con sé Gabriele Gallico, che parlava inglese, io mi ricordo mio papà che diceva: “Ma diglielo a ’sti inglesi che è roba mia, che io, adesso basta, devo riaprirlo”.
[…] Intanto Vercelli si è risvegliata, tornavano tutti e mio papà, finalmente, ha potuto riaprire il negozio con niente, è andato a chiedere ai suoi fornitori a Gallarate se gli davano della merce in deposito, perché non aveva né soldi né niente, tutti gli han dato un po’ di stoffe». Pia continuò gli studi e si iscrisse all’Istituto tecnico Cavour per ragionieri per giungere poi al diploma.
Per la signora Alberta Cingoli Sacerdote il reinserimento nella società torinese, quando poi tutta la famiglia Sacerdote si trasferì definitivamente a Torino, avvenne senza grossi problemi: «Ah!, sì, sì, il reinserimento a Torino è stato buonissimo, subito, sì, sì, poi io ero ancora che non conoscevo tanto l’ambiente ebraico che c’era, perché eravamo stati pochi mesi in fondo prima di tutto questo. […] Avevo dei parenti che frequentavo…».
Gli ebrei che tornarono furono nuovamente considerati cittadini italiani e non più solo “ebrei” come aveva voluto la feroce legislazione razziale. In loro si manifestarono sentimenti di gioia misti a rabbia e commozione per aver riconquistato la piena parità. Tutto ciò traspare soprattutto dal racconto commosso di Pia Segre: «[…] ma la cosa più commovente, questo devo dirlo, è stata che mio papà, aveva il negozio in piazza Massimo d’Azeglio… Andavamo a scuola al Cavour e venivo a casa con le mie compagne di scuola […] Mio papà chiudeva il suo negozio e, molto contento, veniva all’angolo di via Gioberti e mi diceva: “Non sai che piacere mi fa vederti con le tue compagne di scuola”, io ho voluto bene a mio papà, e diceva un’altra cosa: “Vado a votare volentieri, non per questi quattro cretini di politici che ci sono adesso”, perché la prima volta che è andato mio papà ha detto: “Vado a votare perché ho di nuovo i diritti civili”, e allora dicevano la famosa frase: “Signor Aristide Segre ha votato”, lui era ingenuo, era un uomo semplice e aveva apprezzato questa cosa».
Sempre dal racconto di Pia Segre si apprende inoltre che, nei mesi successivi alla fine della guerra, il tempio israelitico vercellese venne riaperto dalla brigata americana: «C’era un gruppo di ebrei americani e un rabbino in divisa, con tutti questi soldati ebrei hanno ripulito il tempio, come un miracolo, il tempio era pieno di soldati americani, lo ricorderò sempre, e questo rabbino ha fatto una funzione molto commovente e aveva riaperto lui il tempio».
I ragazzi che tornarono dopo la Liberazione, gli stessi uomini e donne che oggi mi hanno offerto la loro testimonianza, continuarono poi a vivere a Vercelli e, crescendo, intrapresero cammini differenti: alcuni rimasero in città, molti emigrarono; si sposarono, operando le loro scelte matrimoniali non necessariamente nell’ambiente ebraico; ebbero dei figli, i quali fecero a loro volta le loro scelte in campo religioso.
Mario Pollarolo sposò una cattolica e come lui Dario Colombo. Dal matrimonio di Dario nacquero due figlie, a proposito delle quali egli afferma: «Le mie figlie le ho portate in Israele, da ragazzine, avevano quindici anni, sedici; non so se si sentono molto ebree, non abbiamo mai discusso questa questione. Io ho fatto un patto con mia moglie, che lei non avrebbe inculcato nulla della sua religione e io avrei fatto altrettanto, poi loro potevano scegliere, far quel che volevano, non hanno scelto».
Bisogna inoltre ricordare il costante impegno di Dario Colombo a favore del mondo ebraico. Esponente della piccola Comunità vercellese, nel 1994 fu protagonista di un episodio “coraggioso”, considerando la sua posizione e quello che fece: «Io accettai, due anni fa, che Alleanza nazionale deponesse una corona ai deportati, loro non parlarono e parlai io, dissi che questo era, simbolicamente per me, un modo per far sì che i bambini, che erano nelle carrozzelle, non si odiassero in futuro, che questa divisione doveva, dopo cinquant’anni, cessare, che non avevo dimenticato niente, che non avevo perdonato niente, ma che non volevo che si perpetuasse l’odio, questo era il mio intendimento e così ho fatto. Loro non dissero una parola e credo di aver fatto una cosa che dai miei correligionari è stata molto criticata, da molti cittadini, anche antifascisti, è stata apprezzata come atto, non uso il termine riconciliazione, ma di non perpetuare l’odio, questo è il mio intendimento. Io con questo non ho sputato su quelli che sono morti ad Auschwitz, ma non sputo neanche sui caduti della Repubblica sociale. Ma con questo io non sono mica passato dalla parte dei fascisti, ho ritenuto di dovere fare una cosa, perché non si perpetui l’odio, prendo atto che Alleanza nazionale ha ripudiato le leggi razziali, condannandole, e allora?, qualcosa dovevo fare anch’io, l’ho fatto».
E ancora Dario Colombo rivendica il fatto di essere sionista: «Sì, sono un sionista: ho un attestato dell’esercito di Israele per la guerra dei sei giorni, io sono stato in Israele quando Saddam Hussein lanciava i missili, ormai ero troppo vecchio per fare qualche cosa, e poi Israele non si è mosso, solo per solidarietà, non è una gran cosa, è molto poco, ma io per quello che considero veramente il mio paese, faccio queste cose. È una questione di sentimenti, uno è patriota, un altro non lo è, ma più che una questione di patriottismo io faccio un altro ragionamento: un soldato di Israele che è caduto sul campo, è caduto non solo per il suo paese, ma anche per tutti gli ebrei della diaspora. Io sono ebreo, italiano, vercellese e rimango ebreo, italiano, vercellese, però amo Israele».
Diversa invece la storia di Pia Segre che sposò un ebreo di Cuneo e, con il matrimonio, si trasferì in quella città. Da quell’unione nacquero poi due figli entrambi di religione ebraica.
Anche Pia ed il marito tengono a coltivare e tramandare le tradizioni e la cultura ebraica nel nuovo luogo di residenza, Cuneo, non tanto in un rapporto privilegiato con Israele: «Viaggio, sì, sono già andata [in Israele], però mio marito è sempre rimasto più cuneese, attaccato alla vita di Cuneo e ben voluto… è amico con il vescovo, io cerco di fare l’amicizia ebraico-cristiana, mi chiamano e io rispondo; lui adesso ha le chiavi del tempio, si è occupato di ristrutturarlo. C’è stato un rifiorire di un ritorno di un gruppo, per cui mio marito si è dato da fare, si è impegnato con la religione, con offerte sue, con la comunità, ha rimesso un po’ in ordine il tempio che era andato giù e lo apriamo a Yom Kippur, che è la festa più importante, religiosamente ebraica, il giorno del digiuno, e lo apriamo, lui è contento di questo fatto».
La storia della Comunità ebraica vercellese e della sua rinascita in città, a guerra finita, non fu, naturalmente, solo una storia di singoli individui e di singole esperienze, ma di un gruppo intero, di chi riuscì a salvarsi fuggendo agli arresti e alle deportazioni: purtroppo i dati relativi agli ebrei nel dopoguerra sono troppo scarsi per trarne una ricerca dettagliata. Certo è che il gruppo ebraico vercellese, già di modeste dimensioni prima del conflitto, nel dopoguerra si ridusse ulteriormente.
Il perché, dopo il 1945, rinasca a Vercelli una comunità di dimensioni così limitate va ricercato in diverse direzioni: va considerato in primo luogo che le persecuzioni razziali crearono una vera e propria frattura nelle vite degli ebrei, tra ciò che era stato prima e ciò che sarebbe stato dopo.
Molti dovettero ricrearsi un’esistenza, in quanto la loro vita precedente era stata spazzata via; alcuni in particolare furono costretti a ricominciare in una città diversa da quella di origine. Così bisogna constatare che molti ebrei non fecero più ritorno a Vercelli; alcuni invece vi tornarono per emigrare però poco dopo.
Rispetto ai dati già esaminati precedentemente[5], nei quali si evidenziava che la Comunità ebraica comprendeva 183 individui, risulta che dopo il 1945 emigrarono 31 individui, 14 maschi e 17 femmine: si tratta di una percentuale molto alta, segno evidente della decadenza della piccola Comunità ebraica di Vercelli. Nettamente inferiore fu il numero di coloro che, dopo il 1945, si trasferì in città; i dati indicano in tutto solo 7 individui, 2 maschi e 5 femmine[6].
Le informazioni, ottenute soprattutto all’anagrafe di Vercelli, offrono anche la possibilità di delineare il quadro della situazione matrimoniale degli ebrei ritornati a Vercelli dopo la guerra. I casi sui quali si sono potute svolgere le indagini sono certo molto pochi, a causa della lacunosità delle notizie; è inoltre impreciso il numero egli ebrei residenti a Vercelli dopo il 1945.
Tuttavia, dall’elaborazione degli scarsi dati a disposizione, emerge che la scelta del coniuge, rispetto agli anni precedenti la guerra, si orienta prevalentemente verso individui estranei al mondo ebraico; sono soprattutto i maschi ad orientarsi verso il mondo cattolico, rivelando una crescente apertura verso l’esterno del mondo ebraico; da parte delle donne, invece, sembra esserci una maggiore tendenza a rispettare la tradizione sposando un uomo della stessa religione.
Tale scelta può anche ricondursi al fatto che ormai, nel dopoguerra, a causa della debole consistenza del gruppo ebraico vercellese, molti ebrei non si sentivano più vincolati al loro “ambiente”, tanto da poter operare scelte libere da qualsiasi costrizione, o dovere, o senso di appartenenza[7]
Nonostante il ritorno a Vercelli di alcuni ebrei che avevano lasciato la città prima e durante le persecuzioni, la piccola Comunità ebraica vercellese non tornò più ad essere la stessa: la vecchia generazione, con le sue personalità di spicco, a poco a poco si stava spegnendo; tra coloro che rientrarono nella città, molti ripartirono poco dopo, fino a quando il gruppo ebraico vercellese finì per scomparire quasi del tutto. Oggi di quel mondo rimangono solo pochi rappresentanti, la maggior parte dei quali non vive più a Vercelli.
Note
[*] ⇑ Saggio tratto dalla tesi di laurea Ebrei e persecuzioni razziali nel Vercellese, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, a. a. 1996-1997, relatore prof. Fabio Levi.
[1] ⇑ Precisamente: intervista a Pia Segre, a Cuneo, il 14 gennaio 1997; intervista a Dario Colombo, a Vercelli, il 26 novembre 1996; intervista a Mario Pollarolo, ad Asigliano Vercellese, il 17 novembre 1996; interviste ad Alberta Cingoli Sacerdote, a Torino, il 22 febbraio 1995 rilasciata in una IV elementare frequentata dalla figlia del prof. Fabio Levi, relatore della tesi e il 13 febbraio 1997; manoscritto di Aldo Cingoli, la cui stesura avvenne dopo il 30 aprile 1984 a Vercelli; diario di Alberto Sacerdote. Il diario di Alberto Sacerdote è stato pubblicato con il titolo Oltre il confine. Diario di una famiglia ebrea, a cura di Alberto Lovatto, ne “l’impegno”, a. XV, n. 3, dicembre 1995.
[2] ⇑ Si veda nota 1.
[3] ⇑ A Meina si compì il primo massacro di ebrei nel nostro paese ad opera di reparti delle Ss, che trucidarono cinquantaquattro innocenti senza alcuna distinzione di sesso e di età.
[4] ⇑ Alberto Lovatto, Ebrei in provincia di Vercelli durante la Rsi: la deportazione, in “l’impegno”, a. IX, n. 3, dicembre 1989, pp. 21-29.
[5] ⇑ Si vedano notizie relative agli spostamenti in Cristina Merlo, La comunità ebraica di Vercelli nel 1943, in “l’impegno”, a. XXIII, n. 2, dicembre 2003, pp. 77-78.
[6] ⇑ Si sono analizzati anche i luoghi scelti come meta degli spostamenti e si è notato come le emigrazioni si dirigessero principalmente verso il Piemonte: 15 persone, 5 maschi e 10 femmine; seguono poi altre regioni quali Lombardia, Toscana, Liguria, Veneto, Emilia. I pochi ebrei che, invece, giunsero a Vercelli dopo il 1945 provenivano principalmente dal Piemonte, seguito dalla Lombardia e in un solo caso dall’estero.
[7] ⇑ Su 14 matrimoni con persone di religione non ebraica, 12 sono stati contratti da uomini e solo 2 da donne; dei 3 matrimoni celebrati tra persone entrambe di religione ebraica, 2 sono donne e 1 uomo. Dei 17 matrimoni, 11 furono celebrati a Vercelli, 2 a Torino, 1 a Brescia, 1 a Milano, 1 a Saluggia e 1 in Svizzera.
Per quanto concerne l’età, 8 individui, di cui 5 uomini e 3 donne, si sposarono tra i 21 e 30 anni; altri 7 individui, di cui 6 uomini e 1 donna, si sposarono in età compresa tra i 31 e i 40 anni; 2 uomini tra i 41 e i 60 anni.