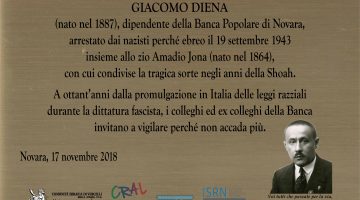Maria Ferragatta – Orazio Paggi
articolo pubblicato ne “l’impegno”, , a. XXV, n. s., n. 1, giugno 2005
L’assenza è un tradimento ontologico. È la mancanza di qualcosa o qualcuno che dovrebbe esserci e invece non c’è, e la cui non-presenza appare come una violazione dell’ordine dell’Essere.
Ad Auschwitz si percepisce in modo intollerabile l’assenza dei milioni di ebrei cancellati dalla “soluzione finale”. Un’assenza che è incubo, vergogna e monito.
Nel suo film “Finis terrae” (proiettato durante le celebrazioni organizzate dalla città di Biella per la Giornata della Memoria e ospite del Festival cinematografico Infinity di Alba) Manuele Cecconello sceglie, appunto, la rappresentazione dell’assenza per descrivere Auschwitz a sessant’anni dall’ingresso dei russi nel più tristemente famoso campo di concentramento nazista.
In “Finis terrae” che è, come dice il titolo, l’immagine quietamente apocalittica di una possibile “fine del mondo” l’Olocausto viene raccontato per sottrazione: sottrazione del colore, della voce fuori campo a commento delle immagini, sottrazione dei corpi di chi non c’è più, della sofferenza stessa, suggerita ma non mostrata, con un approccio estetico e narrativo opposto a quello di Alain Resnais in “Notte e nebbia”, dove l’abominio appare nella sua sistematica mostruosità nei filmati d’epoca in bianco e nero, che si alternano alle sequenze a colori in cui i luoghi della deportazione sono ripresi come sono oggi, abbandonati e inoffensivi.
Cecconello ci guida in un viaggio verso e dentro l’orrore della storia, che è anche viaggio dentro noi stessi. Fin dall’incipit il nostro punto di vista si identifica con quello (antico) dei deportati e con quello (recente) di chi si reca in pellegrinaggio ad Auschwitz.
Dal treno in corsa vediamo il paesaggio che fugge via, osserviamo le rotaie, simbolo ricorrente nella filmografia del regista, che qui assumono una connotazione angosciosa, non più espressione di apertura verso un altrove da cercare e scoprire, ma percorso obbligato che conduce alla morte. Attraverso il finestrino gli alberi si confondono in una macchia grigia. Scorrono le case, uno stormo di uccelli si alza in volo, e uno stupore ammutolito ci invade mentre l’immagine sgranata si fa buia.
La prima parte del viaggio è terminata: siamo davanti al campo. Appaiono ben nitidi la scritta “Arbeit Macht Frei” e i camini, emblemi della macchina dello sterminio. La macchina da presa sembra esitare davanti al cancello, poi entra, ed ecco l’“assenza” farsi sempre più tangibile nelle ripetute inquadrature del suolo, un tempo affollato e ora vuoto. Sfilano davanti ai nostri occhi i resti delle vite spazzate via: le baracche deserte, le camerate stipate di letti, le foto alle pareti, i cumuli di arti artificiali, stampelle e rottami.
Tutto è dimesso, rugginoso, come in una fabbrica in rovina. Solo le forche parlano esplicitamente degli assassini perpetrati, ma lo fanno in un modo indiretto, allusivo. Questa obbedendo al tabù di André Bazin che interdice la messa in scena della morte è forse l’unica possibilità di rappresentare un abominio che non è rappresentabile: evocarlo nell’anima.
Passiamo attraverso corridoi deserti, a cui le finestre sbarrate dalle inferriate non danno luce. Seguiamo i reticolati sormontati dal filo spinato, una barriera invalicabile che delimita il girone d’inferno in cui siamo caduti. Il silenzio, rotto solo dal cinguettare degli uccelli, è totale, come nei cimiteri.
Riappaiono le rotaie, sentiamo i latrati dei cani, e voci, comandi imperiosi un’eco del passato che si materializza per un istante. Poi lo schermo si oscura e nel buio rimbomba il clangore di una porta che si chiude, inghiottendo i prigionieri e ricacciandoci fuori, fra i vivi.
Ancora un’inquadratura, un cielo percorso di nuvole, mentre si levano le note dell’“Adeste fideles” e in sottofondo si odono voci di bambini. Poi tutto torna buio.
Sono quel coro e quel buio a chiudere “Finis terrae” con una cifra problematica, se non ambigua. Perché lo sguardo che dal suolo si alza finalmente verso l’alto, l’inno sacro che invita i fedeli ad adorare il Dio fatto uomo, sembrerebbero aprire alla speranza di poter trovare una risposta al perché del Male. Ma c’è quel buio che cancella ogni cosa, ci sono le voci infantili quelle dei bambini “passati per il camino” che richiamano alla memoria il grido di ribellione di Ivàn Karamazov: non c’è armonia ultraterrena, non c’è Verità celeste che possa dare un senso al dolore dei bambini. Eppure…
Eppure ci sono le parole che introducono “Finis terrae” a offrire una chiave di lettura ben precisa: “Ovunque incroci lo sguardo di chi non ha più occhi,/ percepisci il tocco di chi non ha più mani,/ odi la voce di chi è stato cancellato/ chiedere perché./ E il respiro si fa corto./ L’eco di un vuoto/ si insinua fra le pieghe della memoria/ come un ordigno./ Se non ce ne prenderemo cura”. Se non ce ne prenderemo cura.
Fra i fantasmi invendicabili di Auschwitz veniamo risucchiati noi stessi in un gorgo di spavento e di terrore che offusca le immagini, ammutolisce i suoni. Non possiamo capire, non possiamo spiegare. Ma possiamo ricordare e fare del ricordo un monito che gridi al mondo: mai più.
Per fare chiarezza sugli interrogativi rimasti in sospeso ci siamo rivolti direttamente al regista, Manuele Cecconello.
Il treno, la ferrovia, sono un tema ricorrente nel suo cinema. Hanno un significato simbolico intenzionale o sono un’ossessione inconscia che affiora ogni volta che si mette dietro la macchina da presa?
Questa seconda soluzione, credo.
Reticolati, cancelli, filo spinato: quale valore incarna in “Finis terrae” l’“estetica della barriera”?
Il nero, quella assenza di luce dentro gli stanzoni adibiti a camere a gas. Quel genere di nero è una barriera insormontabile. Per porte e cancelli ci sono chiavi, per il filo spinato tenaglie. E poi sono un genere di barriere che si danno, per così dire, alla lettera, e si sottopongono quindi anche ad un vaglio retorico. In “Finis terrae” il nero e il silenzio il quale si percepisce tra due suoni sospesi sono una barriera.
L’inizio del film pare un omaggio a Sokurov. Fino a che punto il suo cinema l’ha influenzata nel trattamento delle immagini?
L’opera di Sokurov desta in me profondo sgomento e partecipazione. Sono grato di poterne essere influenzato. È un artista che parla il linguaggio della verità ad ogni fotogramma. Ed è il linguaggio che ho adottato anch’io.
Per restare in ambito di omaggio artistici, fino a che punto “Finis terrae” è debitore di “Fortini/Cani” degli StraubHuillet?
È possibile ravvisare alcune vibrazioni comuni. Si tratta della prassi di prendere posizioni morali che vadano al di là della nostra “durata” biografica.
Pur affrontando un tema storico lei non utilizza immagini documentaristiche d’epoca. Si tratta di un atteggiamento etico o di una scelta poetica?
Dentro al perimetro di Auschwitz il senso del tempo subisce un drastico cortocircuito. Ho operato scelte espressive per creare una tensione emotiva che potesse emulare la particolare prostrazione che mi ha colpito durante quella visita.
L’“Adeste fideles” finale è una provocazione o svolge una funzione ecumenica in senso più ampio?
La scelta di compiere questo viaggio è stata fatta da me e dalla sceneggiatrice Grazia Ghitti all’interno di un più ampio percorso di ricerca religiosa. In particolare ci premeva indagare il problema della teodicea, la natura del male. Apponendo in chiusura del film quel brano, ho inteso denunciare un certo smarrimento, una dicotomia lacerante. Appellarsi a Dio per chiedere salvezza di tanto scempio può equivalere a considerarne la non onnipotenza. Oppure anche chiedere perdono alle vittime con quella musica tradizionalmente associata alla nascita, a qualcosa di nuovo e buono che giunge. Ho posto a me stesso delle questioni. Spero di potervi rispondere nei prossimi film.
Considera “Finis terrae” un film politico?
Lo considero un film-preghiera.