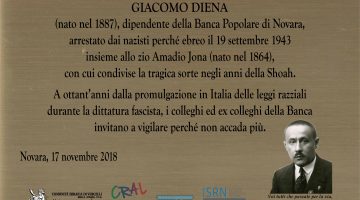Nedo Bocchio
articolo pubblicato ne “l’impegno”, a. IX, n. 1, aprile 1989
Non c’erano ragioni, in quell’estate del 1938 nella piccola comunità israelitica di Biella, di pensare che qualche cosa di traumatizzante sarebbe successo. Non c’erano state avvisaglie e, in generale, non si riteneva che la politica del regime potesse avere svolte antisemite. Tutt’al più, in chi seguiva con attenzione gli avvenimenti tedeschi, poteva risorgere un antico sentimento di paura, sollecitato dai racconti che facevano i profughi provenienti dai territori del Terzo Reich.
In Italia gli ebrei nel 1938 sono circa settantamila e sono in aumento. Non perché siano in espansione le nascite, ma per gli arrivi di famiglie dalla Germania dove, dall’ascesa di Hitler al potere nel 1933, le leggi razziali restringono in modo sistematico e progressivo gli spazi di libertà individuale e di possibilità operativa economica e professionale. I nuovi arrivati si stabiliscono soprattutto nelle grandi città: Milano, Roma, meno a Torino, meno che meno a Biella.
Le famiglie ebraiche di Biella si sentono un poco estranee a quei grandi avvenimenti europei. Forse pensano che l’Italia non sia terra da crociate antisemite. Una certa intolleranza cattolica è da tempo messa in conto. E, per contro, c’è la pressoché totale integrazione nella società e nello Stato italiano. La borghesia israelitica sa di essere stata molto importante nel processo di unità nazionale.
A Biella le famiglie israelitiche si occupano di commercio tessile e di industria, sono attive nelle libere professioni, nella scuola e in altri settori statali. Alcune sono in città da trecentocinquant’anni e con ragione possono dire di essere più biellesi di molti biellesi.
È in questo clima che, ad un tratto, debbono prendere atto che tutto sta mutando e la loro felice integrazione nello Stato è respinta dal regime fascista.
Qual è il ricordo di quei drammatici anni? Emilio Jona, avvocato e studioso di canti ed espressioni musicali popolari e Alberto Treves, ingegnere, presidente della Comunità israelitica di Vercelli e Biella, per tanti anni impegnato politicamente nell’amministrazione del Comune di Biella e nel Comprensorio, ci aiutano ad avere un’idea del clima e delle pratiche conseguenze suscitate dalle leggi razziali.
Emilio Jona aveva allora undici anni e aveva appena terminato la prima ginnasio. Frequentava la scuola della borghesia biellese colta, ma non necessariamente ricchissima. Il padre, Alessandro Jona, era tra i più noti avvocati dell’intero circondario.
«Non avevo, essendo un bambino, una percezione della Comunità in quanto tale, ho invece un ricordo vivo di esclusione, anche traumatica. Ho un ricordo preciso, persecutorio, di bambini nei confronti di bambini, ma non dipendente dalla volontà dei bambini.
La scuola era finita e io fui invitato a festeggiare, con gli altri bambini della mia classe, in una villa della Valle di Mosso. A quei tempi era abbastanza frequente che nelle famiglie della borghesia industriale biellese vi fossero delle istitutrici tedesche. In questa casa c’era una fraulein la quale, evidentemente saputo che ero ebreo, cominciò a costruire una sorta di gioco persecutorio nei miei confronti. Durò praticamente tutta la giornata e consisteva nel fare in modo che fossi sempre io a pagare pegno, a subire le punizioni, a “esser sotto”. Ricordo comunque molto bene che verso la fine della giornata mi ribellai a questa specie di persecuzione picchiandomi con altri bambini.
Ma il ricordo più vivo è dell’aspetto della fraulein: ho ancora presente il volto di quella giovane tedesca.
Dunque, picchiai duramente e me ne andai. La casa era in prossimità del percorso della ferrovia Biella-Valle Mosso. Il muretto di cinta confinava con la massicciata. Quando passai davanti, sulla carrozza ferroviaria, vidi che sul muretto vi erano tutti i bambini schierati con la fraulein in testa che mi facevano l’orecchio di maiale.
Questo è stato il primo contatto con la mia “diversità”. Fin allora ero stato perfettamente integrato. Avevamo una vita perfettamente normale. Sì, mio padre mi portava al tempio nelle feste comandate, ma nulla più. Gli ebrei italiani erano degli assimilati, tendevano ad assimilarsi.
Le leggi razziali colpirono pesantemente la mia famiglia. Mio padre dovette separarsi dallo studio associato nel quale aveva fin a quel momento lavorato. Le leggi non permettevano che un avvocato ebreo, e questo valeva per tutte le libere professioni, fosse in associazione con avvocati ariani. Ricordo il trasporto dei mobili e dei libri di mio padre che con un carro fece dal vecchio al nuovo studio».
Le leggi razziali erano in realtà più restrittive. Un ebreo non poteva esercitare le professioni liberali, non poteva essere dipendente della pubblica amministrazione o di altri settori dello Stato, non poteva avere industrie con più di cento dipendenti, era escluso dalla scuola pubblica come insegnante e come studente, non gli era concesso tenere domestici ariani e altre cose ancora. Questi divieti avevano alcune attenuazioni per i cosiddetti ebrei discriminati. I discriminati erano coloro che si erano guadagnate benemerenze nei confronti della patria.
Per i giovani ebrei che non avrebbero potuto frequentare le scuole pubbliche, i decreti attuativi delle leggi razziali prescrivevano la formazione di scuole, di solo livello elementare, separate. In realtà tali scuole non entrarono mai in funzione. A queste necessità provvidero le comunità. Molto nota è sempre stata la scuola ebraica di Torino. Era sorta nel lontano 1823 come scuola confessionale, ma nel ’38 la necessità di accogliere tanti ragazzi espulsi dalle scuole statali ne imporrà l’ampliamento con la nascita delle medie e delle superiori classiche e tecniche. In breve la scuola ebraica torinese divenne un centro vivo e cauto di antifascismo e, allo stesso tempo, un formidabile centro educativo, ricco com’era di prestigiosi insegnanti, anch’essi colpiti dai provvedimenti razziali.
Ricorda ancora Jona: «Mio padre fu dichiarato ebreo discriminato. Aveva combattuto nella grande guerra ed era stato decorato. Per questa ragione gli
era concesso di proseguire l’attività di avvocato, ma da solo.
Per quanto riguarda la scuola io, naturalmente, fui estromesso dal ginnasio di Biella. Mi trasferii allora a Torino presso gli zii per frequentare la scuola ebraica che nel frattempo la Comunità aveva organizzato. Lì feci le medie e il liceo. In quella scuola vennero poi tutti i miei tre fratelli. Anzi, quando furono tutti in età scolare ci riunimmo con mia madre a Torino; mio padre restò a Biella per il lavoro. Questa situazione durò fino al 1943, fino all’arrivo dei tedeschi. Allora la situazione si fece davvero pericolosa e gli episodi della nostra clandestinità sarebbero molti, ma ancora una volta percepimmo il grado di pericolosità solo dopo l’episodio dell’omicidio del gruppo di ebrei a Meina, sul lago Maggiore».
Alberto Treves alla promulgazione delle leggi razziali aveva compiuto 21 anni ed era cadetto della Regia accademia di artiglieria e genio a Torino. C’era entrato nell’ottobre del 1935 e, superato il primo periodo di addestramento, aveva prestato giuramento nel 1937. Da quel momento è in forza all’esercito con il grado di sottotenente in servizio permanente effettivo. Un anno più tardi verrà espulso dalle forze armate.
Sullo “stato di servizio” un timbro in caratteri tutto maiuscolo dice: “razza ebraica”. Nella descrizione dello stato è scritto: «dispensato dal servizio permanente e collocato in congedo assoluto dal 1 gennaio 1939 XVII, ai sensi del R.d.l. 22 dicembre 1938 XVII. Cessa di far parte dei ruoli degli ufficiali».
Ma sentiamo questa storia raccontata dallo stesso Treves. «La mia famiglia era formata da mio padre, medico condotto e ufficiale sanitario a Pralungo, mia madre e tre figli. Mio padre era medico condotto dal 1915; appena vinto il concorso fu richiamato e partecipò alla guerra del ’15-18. Tutto andò poi regolarmente fino al 1938 quando fu licenziato e io fui espulso dall’Accademia. Erano sopravvenute le leggi razziali e nessun ebreo, in quanto nemico della patria, poteva essere dipendente dello Stato e, a maggior ragione, delle forze armate. Mio padre aveva sessant’anni quando lo licenziarono, il colpo per lui fu molto forte e poco tempo dopo morirà.
La cosa sgradevole che ancora ricordo è il modo in cui fui cacciato e il fatto che dei duecentocinquanta tra allievi e istruttori che componevano l’Accademia non uno venne a salutarmi, a dirmi: “Ciao, mi dispiace”.
Per la mia famiglia cominciava un periodo tragico che durerà fino alla fine della guerra. Sette anni di tribolazioni per sbarcare il lunario. Le leggi razziali, che io ricordi, avevano avuto effetto diverso sulle famiglie ebraiche di Biella. Ad esempio gli Ottolenghi emigrarono subito in Israele; dei Vitale uno andò in Israele e un altro fratello negli Stati Uniti. Le situazioni erano le più diverse, per qualcuno mancava la possibilità economica di andarsene, altri ritenevano che non fosse il caso. Per me era impossibile. Dovevo pensare alla anziana madre, solo mia sorella lavorava e c’era un altro fratello più giovane, che naturalmente fu espulso dalla scuola.
E stata una mazzata perché nessuno poteva immaginarsi che all’improvviso capitasse un tale scombussolamento. C’erano state delle avvisaglie mesi prima. Sulla “Stampa” era uscito un trafiletto intitolato: “Ebrei antifascisti arrestati a Torino”. Era la prima volta che accoppiavano i due termini “ebrei” e “antifascisti”, la cosa ci mise in allarme. Sapevamo dell’arrivo dalla Germania di numerosi profughi, ma delle persecuzioni era più quello che si intuiva che quello effettivamente sentito. Da noi non c’era stato un crescere di antisemitismo anche se i giornali avevano cominciato a scriverne. Al massimo si poteva sentire qualche barzelletta in più sugli ebrei, mentre ad esempio in Accademia non mi è mai successo di avere, fino all’espulsione, la benché minima contrarietà. Chissà, a proposito di Accademia e di forze armate, quanti furono i cacciati; è un dato che non ho mai visto da nessuna parte e sarebbe bello che lo Stato a cinquant’anni di distanza si ricordasse di questi particolari perseguitati.
Era il taglio dato alle notizie giornalistiche che doveva creare l’antisemitismo, invece l’atmosfera che si era andata creando nel ’38 è quella che allora si chiamava “il pietismo”. Il fatto che conosciuti e apprezzati personaggi della cultura fossero mandati via suscitava grande impressione. Al Politecnico di Torino i tre più noti docenti erano ebrei. Quando furono cacciati tutti i circoli intellettuali restarono particolarmente colpiti. Naturalmente la gente comune non capiva, non conosceva nulla della questione ebraica e se ne disinteressava. Invece quando, dopo il ’43, vi fu la vera situazione di crisi molti di noi ebbero l’aiuto da persone semplici e disinteressate, così come altri, voglio ricordare Michelangelo Vitale, furono venduti da conoscenti forse solo per riscuotere la taglia di cinquemila lire posta sulla testa di ogni ebreo.
Comunque da quel gennaio 1939 iniziai una peregrinazione tra lavori diversi. Lavorai a Milano, disegnavo anime per fusione e prendevo una paga così bassa che non mi bastava per mantenermi. Io invece a casa avevo altri familiari a cui pensare. Mi è persino capitato di dover rendere la buona uscita che l’esercito mi aveva dato perché dopo un po’ era risultato che non ne avevo diritto. Così tra un lavoro e l’altro trascorsero gli anni fino alla fine del ’43. Nel dicembre di quell’anno un bando tedesco imponeva agli ebrei di consegnarsi. Allora con mia madre, già molto anziana, mia sorella, mio fratello e altre due persone attraversammo il confine con la Svizzera».